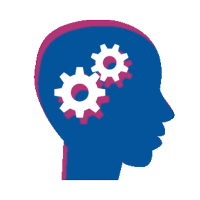«Fatina Sed fu arrestata nel 1944 a Roma e deportata nel campo di sterminio di Auschwitz a tredici anni. Lei e il fratello furono gli unici a sopravvivere della loro famiglia.
«Fatina Sed fu arrestata nel 1944 a Roma e deportata nel campo di sterminio di Auschwitz a tredici anni. Lei e il fratello furono gli unici a sopravvivere della loro famiglia.Solo molti anni dopo riuscì a scrivere la sua storia su un quaderno, fortunosamente ritrovato da sua nipote Fabiana. Attraverso una lingua semplice, diretta, priva di orpelli o digressioni, e proprio per questo estremamente efficace, Fatina riporta i fatti così come si erano svolti e come la sua mente ancora bambina li aveva cristallizzati nella memoria. Sono pagine preziose per la forza e la verità che sprigionano, che ci lasciano attoniti ancora una volta, come se tutto ciò che sappiamo della ferocia del fascismo e del nazismo non fosse mai sufficiente.
Ciò che rende unico questo libro, inoltre, è il lavoro fatto dalle due curatrici – entrambe psicoterapeute – che non si sono limitate a prendere in esame la storia di Fatina, ma hanno tentato di fare luce sulle conseguenze che quell’esperienza inumana ha avuto e ancora ha sulle generazioni successive, sulle figlie e sui nipoti di Fatina, di cui vengono riportate qui le testimonianze».Così si legge sulla terza di copertina del libro di Fatina Sed, Biografia di una vita in più, a cura di Anna Segre e Fabiana Di Segni, uscito pochi giorni fa per i tipi di Elliot.
Il ritrovamento del piccolo taccuino a quadretti su cui Fatina scrive a penna la sua storia non è una finzione letteraria (potete trovare la prima pagina riprodotta nelle ultime pagine del libro), è la fine di un silenzio durato cinquant’anni e ha due moventi potentissimi, espressamente dichiarati alla fine del testo: «Oggi sono madre di tre figlie femmine e ho due nipotini piccoli, Alessandro e Fabio. Spesso loro mi chiedono: “Nonna, cosa hai sul braccio? Cos’è, il numero di telefono?”. Io dico loro che quando saranno grandi la nonna gli racconterà la storia del numero sul braccio. Credo che questo mio scritto possa già essere una testimonianza per i giovani. I ricordi io li sto riassumendo in questo periodo perché vogliono dare la grazia a Kappler, l’assassino delle Fosse Ardeatine… Io credo che ciascuna delle persone sopravvissute in Germania sia libera solo in apparenza, credo che il suo corpo sia libero, ma il suo cervello sia rimasto prigioniero in quei lager dove ha visto morire milioni di persone…».Il silenzio e il tempo che occorre per interromperlo è la prima questione di cui ho ragionato con le due curatrici, con Fabiana in particolare. E’ lei infatti, cresciuta con Fatina, ad aver trovato il taccuino, ad aver “insidiato” il silenzio della nonna, dopo averlo patito, insieme a quello della madre. E’ ancora lei ad aver impiegato un tempo molto lungo – considerata la sua giovane età – per dare alle stampe lo scritto.
La responsabilità di questa “consegna” ha fatto il paio con il senso di colpa di Fatina, condiviso da tutti i sopravvissuti, e la difficoltà di raccontare, di mettere in parola e perciò dipanare il groviglio di sentimenti ed emozioni si è trasferito dalla nonna alla nipote: “[Fatina] si è battuta fino all’ultimo con un ricordo non organizzabile, vivido e indigeribile, indimenticabile, inspiegabile. Questo è il racconto di ciò che è stato taciuto, cui tenta di dare voce: il non detto è parte integrante della narrazione…”. Per Fabiana si trattava di qualcosa di lungamente atteso, da maneggiare con estrema cura, ma anche di “bruciante”, come scrive nel libro.
D’altra parte, le due parole inventate per nominare l’esperienza della Shoah nella vita delle singole persone – deportata/o e sopravvissuta/o – sono parole del silenzio. Non dicono nulla di ciò che è stato, lasciano ai singoli la responsabilità di riempire quell’enorme spazio, da quando si è portati via a forza a quando – incredibilmente – si ritorna.
E’ questo silenzio, questa sproporzione nella responsabilità della narrazione il movente che ha portato Anna Segre ad intraprendere con Fabiana l’impresa di pubblicare lo scritto di Fatina. E’ stata la necessità di restituire ad una dimensione collettiva la storia di questa donna e, con lei, quella di tutti coloro che sono sopravvissuti all’Olocausto, ma soprattutto quella di quanti sono stati raggiunti dalla sua onda lunga, per generazioni e generazioni.
“Che vuol dire per un figlio avere un genitore che ha sperimentato la morte in molte sue forme, che ha dovuto accettare di veder torturare persone care, che ha perso genitori, fratelli, sorelle, o che ha visto cumuli di cadaveri e sofferenze gratuite, e lui stesso si è salvato chissà come e con quale percorso psicofisico?”, si chiedono Anna e Fabiana.
Fin dove è arrivato Auschwitz nella famiglia di Fatina? Chi ha colpito e come e fino a quando?
Nessuno può sostenere per loro questo fardello, nessuno può cancellare dal braccio il marchio indelebile della deportazione. Eppure tutti dovremmo avere la necessità – prima ancora che la responsabilità – di assumere incessantemente l’interrogazione e il dolore per quanto è accaduto.
Ma – come mi fa notare Anna – il “mai più” è stato tradito già troppe volte. E troppi sono stati i tentativi, peraltro riusciti, di sottrarsi ad una responsabilità collettiva e individuale insieme. Troppi i tentativi di replica.
E la stessa istituzione del “Giorno della Memoria”, pure simbolicamente importante, ha paradossalmente contribuito – istituzionalizzandola – a sottrarre senso alla ricorrenza, facendo proliferare forme ossequiose e “politicamente corrette”, di scarsa forza e profondità.
Il libro si apre con il manoscritto di Fatina. Segue una seconda parte “Generazioni successive”, nella quale Anna e Fabiana allargano l’indagine al resto della famiglia, in particolare alle figlie e alla nipote.
Non è possibile non riportare il ritratto che Anna Segre, poeta prima ancora che scrittrice, pone in apertura di questa sessione del libro. Vale più di quanto io possa scrivere o dire, nel tentativo di riportarvi il contenuto del libro e lo scambio – profondo e importante – avuto con le due curatrici.
Figlia di mia madre,
stessi occhi, stesse rughe d’espressione ai lati della bocca.
Lei, con qual veleno silenzioso,
quella termite instancabile nei sogni,
quella memoria automatica all’improvviso nel battito cardiaco,
quel demone sfocato dentro.
Lei, mia madre, con Auschwitz ancora nei neuroni della retina,
più forte di un herpes, più lungo della morte.
E io, ignara, bambina, che le trotterellavo dietro nella disciplina che credevo sua
E adesso so dove l’ha imparata, nell’angoscia degli odori
Adesso so dove l’ha contratta,
nell’irraccontabile che ha occupato la nostra casa per intero,
anche la cucina,
anche le pieghe delle lenzuola,
nell’indicibile che ha sfidato il suo italiano elementare.
Io, che non ho capito o non ho voluto capire
fino a dopo il mio stesso matrimonio.
Lei credeva di proteggermi nel tacermi la verità.
Io non volevo ferirla con domande
E ad ogni domanda mi pareva di brandire un coltello
E di minacciarla con la mia curiosità inopportuna.
Auschwitz nel suo sangue, nel cordone ombelicale,
tra la mia pancia e il suo utero, nei cromosomi,
è la mutazione che ti scianca,
la malattia che ha azzoppato me e le mie sorelle.
Auschwitz, presente indicativo, ancora.
Possono i figli di chi è sopravvissuto parlare dell’esperienza dei genitori?
Non oserebbero certo la prima persona singolare,
anche se hanno respirato, non sapendolo,
il fumo dei forni durante la loro infanzia,
l’impotenza,
l’umiliazione,
la perdita, il terrore
l’odio la morte
ammucchiati indistricabili.
La distruzione dell’anima di mia madre, ho respirato, senza rendermene conto,
e sono ancora qui che balbetto parole che non dicono.
Auschwitz è più lungo della morte, è il filo nero nella tela della nostra vita.
Non è bastato distogliere l’attenzione,
non è servito far come e se tutto fosse normale,
non ha funzionato non saperne nulla.
Mio malgrado, come un’ombra nell’inconscio,
Auschwitz rilascia morte e ancora morte,
anche dopo la morte della mamma.
Anna Segre e Fabiana Di Segni (a cura), Fatina Sed. Biografia di una vita in più, Elliot Edizioni 2017.
*Anna Segre ha curato con Gloria Pavoncello anche il libro Judenrampe. Gli ultimi testimoni
Tags: giornata della memoria olocausto