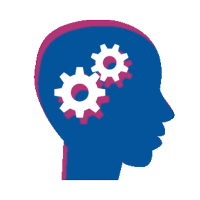Cosa hanno in comune un’università e un sindacato, un ente lirico e un partito, un golf club e una cooperativa, un ospedale e una delle tante associazioni della comunità? Semplice, li lega è l’appartenenza allo stesso magma del non profit. L’autore di questo piccolo ma intelligente libro dimostra i danni prodotti dall’aver inventato un’etichetta per raggruppare troppe cose diverse: un patchwork tenuto insieme da un collante particolarmente forte, ovvero la ragione fiscale. Buono (anche se non nobile) motivo, peraltro: ma può essere veramente questo il collante di un’economia buona? Di un desiderio di solidarietà? Di una volontà di migliorare la società?
Cosa hanno in comune un’università e un sindacato, un ente lirico e un partito, un golf club e una cooperativa, un ospedale e una delle tante associazioni della comunità? Semplice, li lega è l’appartenenza allo stesso magma del non profit. L’autore di questo piccolo ma intelligente libro dimostra i danni prodotti dall’aver inventato un’etichetta per raggruppare troppe cose diverse: un patchwork tenuto insieme da un collante particolarmente forte, ovvero la ragione fiscale. Buono (anche se non nobile) motivo, peraltro: ma può essere veramente questo il collante di un’economia buona? Di un desiderio di solidarietà? Di una volontà di migliorare la società?
Ecco alcuni limiti dovuti all’uso dell’etichetta “non profit”. Il primo è la definizione negativa: essere un “non qualcosa” indica un residualità, non una identità. Il secondo è l’economicismo, ovvero l’assoluto primato dato alla dimensione del profitto, come se l’unico punto di tutta la teoria economia stesse nel conseguire o meno un profitto (E il lavoro dov’è? E il progresso tecnico?). Il terzo è l’assenza della dimensione politica: mentre nel “non profit” alberga anche l’associazionismo che vuole incidere sulle cause che producono politiche dannose.
L’aver inventato l’etichetta ha consentito di creare un’aurea positiva, legata a significati buoni e politicamente corretti: la gratuità e l’altruismo (si pensi al volontariato), la mitica coesione sociale, l’economia buona e il dono... La narrazione di questi buoni sentimenti agisce anche sulla raccolta dei fondi: e questo è un altro vantaggio concorrenziale notevole (oltre alla legislazione fiscale favorevole).
Per tutte queste ragioni dietro il “non profit” buono, nascono organizzazioni che sfruttano queste condizioni per scopi “profit”. È questo il dark side del non profit: le truffe, l’uso scorretto delle risorse, la copertura di attività illecite…
Sia chiaro, l’autore – e noi con lui – ha un’opinione positiva di tutto ciò che agisce responsabilmente per il bene della società: per chi opera ed ottiene risultati socialmente e politicamente positivi. Ma siccome dietro un’etichetta buona (e in questo caso potremmo dire: dietro un’etichetta che richiama il bene ma che non aiuta a compierlo efficacemente) può nascondersi anche il male, allora occorre procedere con più attenzione.
Moro propone parecchie cose. Ci limitiamo a dare qualche titolo: aumentare i controlli interni (i cda) ed esterni (con agenzie di rating); non limitarsi a controllare “le carte” perché, riprendendo Stefano Zamagni, in Italia chi sbaglia una virgola si prende un verbale e chi rispettando le forme elude, evade o froda la fede pubblica spesso la fa franca… Il problema, insomma, è che non sono mai seriamente prese in esame le attività svolte. Bisognerebbe anche non limitarsi a valutare la qualità dell’organizzazione, ma la sua attività e i suoi esiti (che sarebbero l’unica cosa importante!). Soprattutto non bisogna cercare scorciatoie: serve un dibattito serio, informato, esteso ed effettivo, non affidato solo agli addetti ai lavori e (soprattutto) un dibattito che tenga conto della realtà. Il valore e l’utilità sociale di una organizzazione non va misurato in termini assoluti, ma di grado.
Esiste un interesse generale, e dunque possiamo concretamente valutarne la prossimità, pur tenendo conto che l’interesse generale cambia nel tempo ed è materia altamente conflittuale. L’interesse generale è… mobile. È allora questa opera di continua distinzione che oggi appare necessaria: distinguere e graduare i benefici in relazione al tipo di attività svolta, alla prossimità dell’attività all’interesse generale, in base alle modalità di controllo, alla grandezza delle organizzazioni… La parola-chiave è distinguere.
Giovanni Moro, Contro il non profit, Laterza, Bari – Roma, 2014.
Citazioni
“Con questa espressione [terzo settore o non profit – ndr] si intende una categoria del pensiero economico diventata prima teoria sociale, poi provvedimento legislativo di carattere tributario e quindi spazio protetto di azione in cui un po’ tutto è possibile (…) con tutto ciò che ne consegue in termini di dubbia utilità sociale, possibili arricchimenti personali, conflitti di interesse, elusione fiscale, rapporti di lavoro insani, concorrenza sleale con le imprese private, ricchi che diventano più ricchi e poveri più poveri, ‘buoni’ che legittimano vantaggi per i ‘cattivi’”