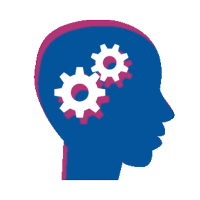L’autore è stato professore, opinionista, ha partecipato a vario titolo in diversi governi della Repubblica, ha risanato aziende. Ha voluto far uscire questo pamphlet per l’elezione del nuovo presidente di Confindustria, affinché Vincenzo Boccia si facesse promotore di un chiarimento radicale e definitivo su dove metter mano per ripartire subito, per evitare di chiedere tutto al Governo, sapendo bene quanto questo non sia possibile, ma ponesse delle scelte praticabili di politica industriale da perseguire nei prossimi anni.
L’autore è stato professore, opinionista, ha partecipato a vario titolo in diversi governi della Repubblica, ha risanato aziende. Ha voluto far uscire questo pamphlet per l’elezione del nuovo presidente di Confindustria, affinché Vincenzo Boccia si facesse promotore di un chiarimento radicale e definitivo su dove metter mano per ripartire subito, per evitare di chiedere tutto al Governo, sapendo bene quanto questo non sia possibile, ma ponesse delle scelte praticabili di politica industriale da perseguire nei prossimi anni.
Forte della propria variegata esperienza e competenza di studioso, Gallo afferma che la crisi della produttività in Italia si è accentuata nel 1998 e solo nel 2014 ha visto un piccolo cambiamento di tendenza.
La causa principale è stata la riduzione degli investimenti in nuovi macchinari, lasciando invecchiare i mezzi di produzione. Le risorse generate e non reimpiegate nello sviluppo hanno remunerato gli azionisti e sono servite a ridurre l’indebitamento verso le banche. L’origine del processo viene qui ricondotta ad una forte riduzione della propensione degli imprenditori a intraprendere in un clima di elevata incertezza politica e sociale causata dal venir meno, uno dopo l’altro, di tutti gli strumenti di intervento pubblico diretto in economia, cui essi erano stati abituati, e per l’impossibilità con l’euro a svalutare.
La richiesta al mondo imprenditoriale è quella di tornare ad avere il coraggio, normale in un imprenditore, di assumersi il rischio d’impresa, per tornare a investire innovando, quando il mercato globale richiede più coraggio e inventiva, risorse tipiche di noi italiani, nonostante la mancanza di una politica industriale che delinei un futuro credibile per l’Italia.
Nelle conclusioni Gallo riepiloga l’analisi e fa delle proposte concrete per favorire una migliore capacità di intraprendere: il contesto regolamentare dovrebbe essere reso più favorevole alla crescita economica, il Parlamento dovrebbe accertare perché le tariffe di reti e servizi sono tanto alte e sproporzionatamente remunerative per le società che le gestiscono, riconsiderare l’aspetto istituzionale delle autorità di regolazione del mercato dei servizi, migliorare la misura del cosiddetto superammortamento, che il presidente di Confindustria Boccia dica pubblicamente quale è la priorità ragionevole prioritaria affinché le imprese sviluppino le loro potenzialità per investire nelle enormi potenzialità del mercato globale.
L’autore ha un punto di vista originale e personale sulla industria italiana e ha chiare idee su come procedere oggi. Il volume è per questo motivo interessante da leggere, perché invita a riflettere sulla storia passata in modo puntuale e, da qui, fare scelte con i piedi per terra. Gallo ha uno stile diretto e preciso, che aiuta nella lettura, perché espone i vari punti di vista e prende posizione su ciascuno di essi.
E’ importante per i nostri mondi associativi e sociali partecipare a questo dibattito, perché il futuro dell’Italia dipende soprattutto dalla capacità di rinnovare la nostra industria manifatturiera, in quanto è quella ancora capace di creare nuovi posti di lavoro di cui siamo “affamati”, soprattutto per i giovani che faticano a trovare impieghi adeguati alle loro aspettative di vita.
Inoltre, con la riforma del terzo settore in fase di definizione dei decreti attuativi, anche per chi volesse percorrere la via dell’impresa sociale è utile conoscere da dove veniamo per intravvedere dove vuole andare in futuro.
Riccardo Gallo, Torniamo a industriarci. A novant’anni dalla “grande crisi”, Guida Editori, Napoli 2016.
Citazioni
"Nel 2005, da una ricerca sulle condizioni per crescere, emerse un’insoddisfacente performance dell’industria nazionale di fronte alla liberalizzazione degli scambi con i paesi mergenti. Le relative cause furono individuate in un’insufficiente dimensione aziendale, una specializzazione settoriale sfavorevole, uno scarso impegno in ricerca e sviluppo" (p. 5).
"Nel decennio trascorso è nato in Italia ma è rimasto soprattutto inespresso un importante dibattito economico e sociale tra quattro scuole di pensiero o per lo meno tra quattro schieramenti che, un po’ semplificando potremmo definire dei “declinisti”, degli “ottimisti”, degli “spacchettatori”, degli “spronatori”. Come esterni hanno partecipato Governo e Confindustria" (p. 5).
"Gli spronatori costituiscono una minoranza culturale inascoltata. Quantificano il declino, ma lo considerano reversibile. […] Io personalmente mi riconosco in pieno in quest’ultima scuola di pensiero" (pp. 8-9).
"L’Italia fa parte di un continente che va gradualmente deindustrializzandosi. Con il volgere degli anni, in Europa, le multinazionali alleggeriscono il loro ciclo di trasformazione industriale e, nei prodotti che vendono, di proprio ci mettono sempre di meno" (p. 14).
"Mentre il contenuto industriale delle multinazionali è calato in Italia come si è detto di cinque punti tra il 2004 e il 2014 (da 29 a 24%), invece quello dell’insieme delle imprese industriali è diminuito di sei punti e, cosa ancor più grave, è scivolato molto giù, passando sa 22 a 16%; poi nel 2014 ha recuperato un punto, risalendo al 17%" (p. 17).
"Gli azionisti delle società industriali italiane si sono distribuiti nell’ultimo quarto di secolo complessivamente il 110% degli utili netti di esercizio, intaccando così le riserve. In altri termini, hanno saccheggiato le loro stesse imprese. […] A fine 1998 le imprese hanno imboccato un percorso di declino e deindustrializzazione progressiva!" (p. 28).
"In termini crudi e suggestivi, possiamo dire che le imprese hanno munto mucche vecchie e, fino alla loro morte, hanno tratto latte proficuo. Invece, la struttura patrimoniale e finanziaria delle società industriali nel corso degli anni si è progressivamente rafforzata" (p. 33).
"La morale della favola è che il collo di bottiglia che frena gli investimenti in Italia ha natura non finanziaria, cioè non dipende da una scarsità di mezzi finanziari, e va cercato altrove. Nonostante la dimostrazione di questa conclusione sia inequivocabile e incontrovertibile, esiste sempre chi la ignora e sostiene il contrario. Non esiste peggior sordo di chi non vuol sentire" (p. 34-35).
"Di fronte all’impoverimento del loro contenuto industriale, cioè all’erosione del lavoro aggiunto, per cercare di mantenere una certa produttività del lavoro (valore aggiunto per addetto), le imprese hanno ridotto l’organico e lo hanno fatto in tutti i modi possibili, con il decentramento delle funzioni aziendali (a partire da alcune di quelle di staff per finire alla produzione) e con la gestione delle situazioni di crisi. Il decentramento ha riguardato prevalentemente le imprese del Centro-Nord, le situazioni di crisi prevalentemente il Mezzogiorno" (p. 38).
"Le piccole imprese hanno un controllo societario di tipo familiare, con una fortissima riluttanza ad aprire la compagine azionaria. Mentre negli altri paesi le imprese nascono piccole e poi se hanno successo crescono, altrimenti falliscono, da noi invece invecchiano rimanendo piccole […] Come notarono alcuni studiosi, il capitalismo familiare italiano, nato in Toscana nel Duecento e cresciuto lungo otto secoli anche grazie alla nozione di accumulazione dei patrimoni, si è fermato allo scoglio del ricambio inter-generazionale, consistente nella mancanza di eredi o di eredi capaci o ritenuti tali dal fondatore" (p. 77-78).
Resta invece insoluto l’altro corno del dilemma, quello ben più importante, direi esistenziale, della propensione degli imprenditori a intraprendere, a investire. Questo dilemma è legato all’incertezza, alla competitività del sistema Italia e alla convenienza economica" (p. 101).
"Sul piano della convenienza economica, parto dal mio convincimento che sarebbe sbagliato prendersela con una categoria, per esempio con gli imprenditori. Se essi dal 1998 sono fiacchi nella loro attitudine precipua, che è quella di investire, vuol dire che sono venute meno le condizioni dell’ecosistema che ne consentono le convenienze e la stessa sopravvivenza della specie. Allora, il governo eccezionalmente consenta a tutte le medie imprese industriali di ammortizzare i nuovi eventuali investimenti nel biennio 2017-18 con coefficienti liberamente scelti, superiori ai massimi fiscali, fino magari a spesarli nel conto economico di ciascuno dei due esercizi" (p. 102).