Il 22 aprile 1954, poco più di 65 anni fa, entrava in vigore la Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato: tre mesi prima, infatti, era stata depositata l’ultima ratifica necessaria (la sesta, quella dell’Australia) affinché lo strumento in questione muovesse i primi passi nell’ordinamento internazionale, dopo un lungo e, per certi versi, travagliato processo di drafting. Si tratta di uno fra i primi e più importanti accordi internazionali in materia di diritti umani, per di più elaborato ed adottato in un contesto a vocazione “universale”, quale quello delle Nazioni Unite (a differenza, per fare l’esempio più celebre, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che l’aveva preceduto, nel 1950, nel più ristretto ambito del Consiglio d’Europa).
La Convenzione presenta i segni del tempo, naturalmente, e, più ancora, dei tempi in cui è nata: i suoi maggiori limiti datano già a quei primi anni del secondo dopoguerra. La sua impostazione, infatti, sconta la ragione principale per la quale è stata elaborata: trovare uno status giuridico a quelle popolazioni che, in Europa, in conseguenza dei radicali cambiamenti politici e territoriali dovuti alla guerra, non potevano più tornare nel proprio paese di origine senza rischiare di subire gravi persecuzioni.
Peraltro, alcuni dei limiti in cui tale logica prese forma giuridica, particolarmente negli elementi che compongono la nozione di rifugiato, sono stati in qualche modo superati nel corso del tempo: la limitazione cronologica e la clausola geografica. Secondo la prima, gli avvenimenti che causano il timore di subire persecuzioni nel paese di origine devono essere “anteriori al 1° gennaio 1951”: per essa è intervenuto il Protocollo di New York del 1967, eliminandola (e solo due Stati parte della Convenzione non lo hanno ratificato: Madagascar e Saint Kitts and Nevis). In virtù della seconda, gli Stati parte potevano scegliere se restringere gli avvenimenti incriminati alla sola Europa: tuttavia, solo quattro Stati hanno utilizzato questa opzione e tre di essi l’hanno in vero “revocata” in occasione della ratifica del citato Protocollo del 1967 (oggi, la sola Turchia si giova della restrizione geografica).
Al contrario, gli altri limiti strutturali della Convenzione tuttora permangono, essendo la prassi riuscita solo in parte a superarli: l’esclusione dei movimenti “interni” di popolazione; l’assenza di un meccanismo di controllo, se non pari a quelli regionali (come la Corte europea dei diritti dell’uomo), almeno simile a quelli che sarebbero poi stati creati nelle stesse Nazioni Unite (quale il Comitato dei diritti umani, “agganciato” al Patto del 1966 sui diritti civili e politici); le eccezioni al divieto di refoulement; i motivi di persecuzione (razza, religione, nazionalità, opinioni politiche e appartenenza a un determinato gruppo sociale).
L’estromissione dei movimenti interni si deve alla circostanza che l’intero onere dello status grava su uno Stato terzo, quello che, per certi versi, si sostituisce a quello, di origine, cui il rifugiato “appartiene” (per cittadinanza o, in caso di apolidia, per abituale residenza). Se una parte della popolazione fugge (a causa, ad esempio, di un conflitto etnico) da una zona ad un’altra del proprio paese permarrà su quest’ultimo la responsabilità di proteggere i propri cittadini. Quello dei c.d. IDPs (“internally displaced persons”) è dunque un fenomeno che il testo della Convenzione non tiene in considerazione. La prassi, tuttavia, avrebbe poi evidenziato una larga diffusione del medesimo, persino maggiore rispetto a quella dei rifugiati: solo chi ha più mezzi, in effetti, può tentare di raggiungere uno Stato terzo in cui trovare protezione; gli altri devono “accontentarsi” di spostamenti meno costosi, spesso, appunto, nei confini del proprio stesso paese.
A tale lacuna hanno provato ad ovviare, su un piano generale, le Nazioni Unite e, più nel dettaglio, l’organo che presidia il controllo sulla corretta applicazione della Convenzione, l’UNHCR (“United Nations High Commissioner for Refugees”). A dire il vero, quest’ultimo non ha, sotto il profilo formale, un mandato che includa gli IDPs, proprio perché essi esulano dal contesto della Convenzione di Ginevra, cui l’UNHCR è indissolubilmente legato. Tuttavia, nell’insieme pressoché sterminato di soft law che l’Alto commissariato produce, come pure nelle sue attività più strettamente operative, finisce per rientrare anche il problema dei movimenti interni: senza, però, che ad essi sia stata data, almeno finora, una soluzione di carattere generale. Solo a livello regionale si è raggiunto qualche risultato più significativo con la Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa, elaborata nell’ambito dell’Unione africana ed entrata in vigore nel 2012.
L’assenza di organi di controllo veri e propri ha determinato alcuni problemi di uniforme applicazione della Convenzione di Ginevra, tuttora aperti. L’Alto commissariato non ha mancato, pur tramite atti di soft law, di provare a risolverli: non sempre, tuttavia, l’opera di “persuasione” funziona, sicché le prassi nazionali, specialmente gli orientamenti dei giudici, tendono a differire in modo significativo. Il rischio è minore nell’Unione europea, grazie alla presenza della Corte di giustizia che esercita, notoriamente, una funzione nomofilattica (anche) sulle norme dell’Unione “attuative”, per certi versi, della Convenzione di Ginevra: ma è un caso isolato. Molti paesi interessati da larghi flussi di richiedenti asilo, come gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia o la Nuova Zelanda, applicano la Convenzione quasi “in solitudine”, se non fosse per il ruolo, come detto non sempre risolutivo, dell’UNHCR. Ad esso le Nazioni Unite hanno pure affiancato un organo di supporto, il Comitato esecutivo (formato peraltro da Stati), ma senza significativi potenziamenti dell’opera interpretativa “centralizzata”, cui l’UNHCR è deputato.
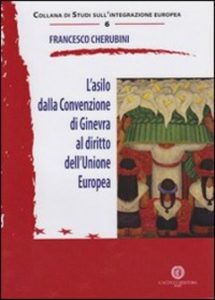 L’assenza di organi di controllo veri e propri ha prodotto una ulteriore conseguenza, ancor più grave rispetto al rischio di una disomogeneità interpretativa: eventuali violazioni della Convenzione da parte degli Stati membri sono sottratte a meccanismi “terzi” di accertamento da parte di un giudice (o simile). A dire il vero, l’art. 38 di detta Convenzione contiene una clausola compromissoria che rende operativa la giurisdizione della Corte internazionale di giustizia in relazione ad “[a]ny dispute between parties to this Convention relating to its interpretation or application”, ma essa non è stata mai utilizzata. A sopperire a questa carenza soccorrono le corti regionali (in primis, la Corte europea dei diritti dell’uomo) e, più in generale, i meccanismi (facoltativi) di controllo sul rispetto dei diritti umani fissati da alcune convenzioni delle Nazioni Unite, come il citato Patto del 1966. Evidentemente, si tratta di un recupero solo parziale, in quanto il riferimento di queste corti e comitati non è la Convenzione di Ginevra, ma quella nella quale essi operano: sicché i loro interventi ad adiuvandum, pure molto incisivi (come sono quelli della Corte di Strasburgo), non vanno oltre l’interpretazione di alcuni principi comuni alla Convenzione di Ginevra, quale soprattutto il principio di non refoulement.
L’assenza di organi di controllo veri e propri ha prodotto una ulteriore conseguenza, ancor più grave rispetto al rischio di una disomogeneità interpretativa: eventuali violazioni della Convenzione da parte degli Stati membri sono sottratte a meccanismi “terzi” di accertamento da parte di un giudice (o simile). A dire il vero, l’art. 38 di detta Convenzione contiene una clausola compromissoria che rende operativa la giurisdizione della Corte internazionale di giustizia in relazione ad “[a]ny dispute between parties to this Convention relating to its interpretation or application”, ma essa non è stata mai utilizzata. A sopperire a questa carenza soccorrono le corti regionali (in primis, la Corte europea dei diritti dell’uomo) e, più in generale, i meccanismi (facoltativi) di controllo sul rispetto dei diritti umani fissati da alcune convenzioni delle Nazioni Unite, come il citato Patto del 1966. Evidentemente, si tratta di un recupero solo parziale, in quanto il riferimento di queste corti e comitati non è la Convenzione di Ginevra, ma quella nella quale essi operano: sicché i loro interventi ad adiuvandum, pure molto incisivi (come sono quelli della Corte di Strasburgo), non vanno oltre l’interpretazione di alcuni principi comuni alla Convenzione di Ginevra, quale soprattutto il principio di non refoulement.
Proprio in relazione a quest’ultimo va segnalato l’elemento forse di maggiore “obsolescenza” di detta Convenzione: il principio di non refoulement è diventato, nel corso del tempo, una delle (poche) norme facenti parte del c.d. ius cogens, il diritto consuetudinario di natura inderogabile – dunque, una pietra angolare del diritto internazionale. Tale evoluzione si deve, appunto, ad una prassi esterna alla Convenzione in esame, che ha portato a superarla, in maniera molto significativa: il suo art. 33, infatti, formula detto principio in termini assai più restrittivi di quanto la corrispondente norma di ius cogens prevede, al punto che non sarebbe inverosimile ipotizzare che, proprio nella misura in cui detto art. 33 introduce eccezioni al principio di non refoulement, sulle medesime si produca l’effetto di nullità (parziale) ex art. 53 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati. Anche rispetto a questo disallineamento, l’opera dei più generali meccanismi di monitoring diventa essenziale: come accennato, però, solo quello incentrato sulla Corte di Strasburgo raggiunge un livello di efficacia sufficiente a tutelare il principio di non refoulement nella sua piena estensione.
Dove la prassi, specialmente la giurisprudenza interna, ha operato con maggiore successo è nei c.d. conventional grounds, cioè i motivi che devono essere alla base della temuta persecuzione nel paese di origine: razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, appartenenza a un determinato gruppo sociale. Facendo leva sul motivo “residuale” (l’ultimo fra quelli citati), i giudici nazionali hanno finito per estendere la protezione a categorie perseguitate per ragioni cui, inizialmente, il testo della Convenzione non era inteso riferirsi: il genere (le donne) e l’orientamento sessuale (gli LGBT e le loro più recenti varianti). Peraltro, tale massiccia operazione “accrescitiva” non poteva, a rischio di sconfinare nella interpretazione contra legem, includere individui rispetto ai quali sarebbe molto difficile riconoscere anche solo il rischio di una persecuzione, tralasciando le problematiche relative ai conventional grounds. Si tratta dei migranti “climatici” e, più in generale, di quelli economici, che sono fuori non solo dal campo di applicazione della Convenzione di Ginevra, ma pure, per certi versi, del principio di non refoulement. Per essi, e sono di gran lunga la maggioranza, il diritto internazionale riserva un destino più amaro: se non hanno altri canali per tentare di migliorare le loro condizioni di vita (il ricongiungimento famigliare, il lavoro, solo per fare due esempi), la difesa dei loro diritti umani resta nelle mani dello Stato che non possono lasciare: il proprio.
Tags: mobilità umana rifugiati





