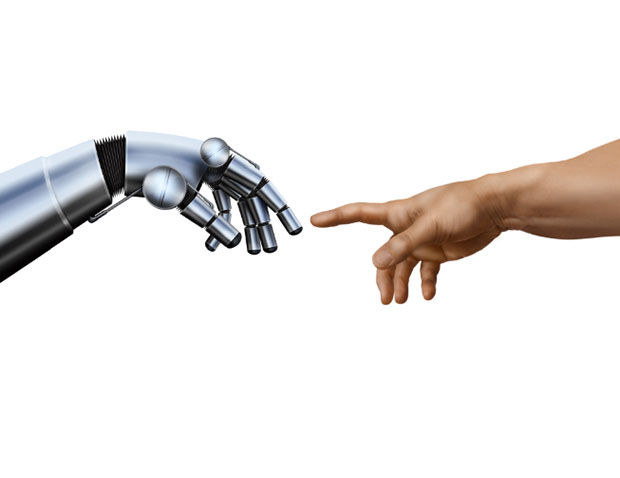Domanda molto pertinente. Fino all’avvento della globalizzazione, avvenuta circa quarant’anni fa, l’economia di mercato era un’istituzione “tendenzialmente” inclusiva ossia cercava di includere tutti coloro i quali avevano possibilità e capacità lavorative. In sostanza eravamo di fronte ad una inclusive society. Con la globalizzazione l’economia di mercato è diventata uno strumento escludente nel senso che esclude tutti coloro che per natura fisica, etnica, religiosa non sono risultati capaci di generare un aumento di produttività. Papa Francesco con grande lucidità ci invita a combattere contro la cultura dello scarto per costruire di nuovo una società includente. In questo senso oggi va ripresa la prospettiva dell’economia civile che era stata messa nel dimenticatoio per le ragioni che ho esposto. Oggi non basta più aumentare il Pil per aumentare l’occupazione, non bastano più i sistemi di welfare per sopperire alla carenza occupazionale.
L’economia civile, che nasce a Napoli nella seconda metà dell’700 ad opera di Antonio Genovesi, era capace già trent’anni fa di proporre la sua prospettiva ma non se ne parlava, non interessava. Il sistema capitalistico, specie nell’attuale fase di jobless growth (crescita senza creazione di posti di lavoro) dovuto all’uso delle tecnologie, digitali e non, non vive come prioritario il problema della piena occupazione, anzi presuppone un livello fisiologico e costante di disoccupazione mentre l’impresa civile intende il lavoro come un fine e non solo come un mezzo o un fattore della produzione. Si evidenzia anche un gap tra i lavoratori creativi e quelli routinari sia in termini di retribuzione che di aumento occupazionale dei primi a danno sei secondi. Aumenta di conseguenza il numero dei lavoratori poveri (working poor) che arrivano a prendere 800 euro al mese. Tutto questo evidenzia come l’idea che bastasse aumentare il Pil per aumentare l’occupazione si sia dimostrata falsa producendo danni spaventosi.
La crisi, da cui stiamo venendo fuori, iniziata nel negli Usa nel 2007 e in Europa nel 2008, è molto diversa dalle precedenti, ha una natura diversa. La crisi del ’29, per citarne una, è stata una crisi dialettica nel senso che è nata da un conflitto tra gruppi sociali, che aveva preso corpo in una determinata società ma che conteneva, al proprio interno, i germi o le forze del proprio superamento. La crisi attuale è invece una crisi entropica che tende a far collassare il sistema, per implosione, senza modificarlo. Questo tipo di crisi si sviluppa ogniqualvolta la società perde il senso. Questa crisi è stata una conseguenza del fatto che non è più chiara la direzione, il dove si vuole andare. L’economia e la finanza sono diventate autorefenziali, fine a se stesse e non oriente alla produzione. Due dati fotografano molto bene il cambiamento avvenuto. Nel 1980 l’ammontare degli attivi finanziari mondiale era pari al Pil mondiale; nel 2013 l’ammontare degli attivi finanziari era 7 volte il Pil mondiale. Ma attenzione! Non basta concentrarci sulle strategie per uscire dalla crisi. E’ importante prima di tutto abbandonare un certo discorso economico, un paradigma che ha cercato di far credere che l’economia sia solo scambio di equivalenti e che il mercato può essere popolato solo da homines oeconomici producendo i disastri che sono sotto gli occhi di tutti. Se non cambiamo paradigma abbracciando quello dell’economia civile, cadremo di nuovo in crisi come quella attuale.
2. Nel suo libro L’economia del bene comune lei afferma la necessità di realizzare una svolta antropologica che consiste nel ritorno dell’economia alla relazionalità? Ci può spiegare in cosa consiste? Come è possibile costruire un sistema economico e sociale che nel suo complesso guardi al bene comune e non solo al bene privato?
Prima di tutto è opportuno chiarire che comune si oppone ad individuale. Il concetto di bene comune è uno dei quattro cardini della Dottrina Sociale della Chiesa e risale al IV-V secolo dell’evo cristiano. E’ quindi un concetto che ha 1600 anni di vita. Basilio di Cesarea e San Benedetto parlano di bene comune e San Tommaso ha costruito la sua Summa Theologiae sul concetto di bene comune.
Il concetto di bene comune va distinto dal concetto di bene totale. Su questo gli economisti sono responsabili di aver prodotto dei grandi danni. Il bene totale infatti è una somma di beni individuali mentre il bene comune è il prodotto degli stessi (dei bei individuali). Ciò significa che il bene comune è qualcosa di indivisibile, perché solamente assieme è possibile conseguirlo, proprio come accade in un prodotto di fattori: l’annullamento di anche uno solo di questi, annulla l’intero prodotto. Essendo comune, il bene comune non riguarda la persona presa nella sua singolarità, ma in quanto è in relazione con altre persone. Il bene comune è dunque il bene della relazione stessa fra persone, tenendo presente che la relazione delle persone è intesa come bene per tutti coloro che vi partecipano. Purtroppo oggi la logica prevalente con cui si opera in economia è ancora quella del bene totale. Ad esempio le persone vengono licenziate perché poco produttive e non si ragiona rispetto al bene della persona, alla sua dignità. La logica dell’economia civile è diversa perché punta ad una politica generale che riguarda la massimizzazione del bene comune. L’economia del bene totale ragiona secondo una prospettiva assistenzialistica che umilia le persone negando spesso la possibilità di opportunità di lavoro decenti.
3. L’umanesimo italiano, come afferma sempre nel libro “L’economia del bene comune”, aveva elaborato 3 principi regolativi dell’attività economica: la divisione del lavoro, l’idea di sviluppo e la libertà d’impresa. Questi tre principi come concorrevano al bene comune? Che cosa è accaduto successivamente? Che cosa ha reso l’economia disumana?
Il 400 è stato il secolo dell’umanesimo civile. Poi nel 500 è arrivato l’umanesimo incivile. L’umanesimo civile, durante il quale si afferma l’economia di mercato civile è la conseguenza immediata della scuola di pensiero francescana. I seguaci di San Francesco, Bernardino da Siena, Bernardino da Feltre, Fra Luca Pacioli cercano di trovare la soluzione al problema di come togliere dalla miseria le popolazioni dell’epoca, adoperandosi per definire le linee fondative e i principi dell’economia civile, di un’etica cattolica in economia. Ma alla fine del 500 le cose cambiano. Il pensiero di Guicciardini e Machiavelli e nello stesso tempo la riforma protestante di Calvino (Lutero e gli altri esponenti della Riforma erano ostili alle questioni economiche, né conoscevano il funzionamento delle istituzioni di mercato) sono le matrici culturali che tengono a battesimo la nascita del modello capitalistico. Alla regola benedettina “ora et labora”, Calvino sostituisce la sua “laborare est orare” (“lavorare significa pregare”), con il che l’ascesi cattolica extramondana si fa ascesi intramondana nella spiritualità calvinista. In questo senso è illuminante il lavoro di Max Weber che nel suo libro L’etica protestante e lo spirito del capitalismo (1904-1905) cerca di dimostrare efficacemente il ruolo privilegiato che i protestanti ebbero nell’organizzazione capitalistica.
Il punto di partenza è Guicciardini secondo il quale la legge di natura di ogni uomo è sempre il proprio interesse. Quindi si porta avanti l’assunto che la natura degli esseri umani sia ego-ista. Machiavelli sul fronte della teoria politica arriva a conclusioni simili. Si afferma via via una concezione dell’uomo visto come un essere individualista, guidato in ogni sua azione deliberata dall’amor proprio, frenato soltanto dall’incontro-scontro con gli interessi degli altri. Nel 600 si sviluppa un nuovo modello di economia di mercato, quello capitalistico. Tutto questo per dire che è sempre il pensiero che guida l’azione. Non bisogna mai dimenticarlo.
4. In che modo l’economia può contribuire alla fioritura di un nuovo umanesimo sociale e civile? Che cosa si attende dal convegno ecclesiale di Firenze?
Oggi stiamo vivendo il passaggio dalla modernità alla post-modernità in cui la dimensione economia gioca un ruolo fondamentale. Siamo in una situazione che presenta delle analogie con quello che accadde 600 anni fa. Quello che è successo negli ultimi quarant’anni ha mostrato le contraddizioni dell’economia globale in particolare sul versante dell’aumento delle disuguaglianze. E’ inoltre emerso un elemento inedito: l’inversione dei ruoli tra mercato e democrazia. La politica si è messa al servizio del mercato. Cosa che non era mai avvenuta prima. E’ necessario invece restituire alla politica il compito di guida dell’economia operando così un’inversione rispetto alla situazione attuale. Per questo motivo serve un nuovo umanesimo che ristabilisca gli equilibri perduti. In questo senso la Chiesa ha fatto molto bene a mettere al centro della sua riflessione questo tema. Infatti il vecchio umanesimo, l’umanesimo civile italiano rappresentò un punto di svolta sociale, politico e culturale.
5. Nel 2008, insieme a sua moglie, ha scritto un libro dedicato al tema della cooperazione? Quale ruolo può avere la cooperazione per uno sviluppo umano integrale? Quali principi può mettere in campo?
L’impresa cooperativa nasce nella seconda metà dell’800 in reazione alle proposte del capitalismo. Oggi le forme di imprese cooperative rappresentano la complementarietà necessaria alla forma di impresa capitalistica. Nel mercato devono operare tipi diversi di impresa ma l’approccio non deve essere più quello dell’800 dove la cooperazione è chiamata a tamponare le falle aperte dal modello capitalistico come ad esempio quella della povertà. In questo senso va notato che anziché vedere la cooperativa come rimedio ad uno specifico “fallimento” della forma capitalistica d’impresa, gli autori classici da Smith a Cairnes e gli italiani Ugo Rabbeno, Giuseppe Mazzini, Luigi Luzzatti, Emilio Nazzani, Antonio Cusumano, videro la cooperazione come la regola, e non già come l’eccezione, del modo di fare impresa.
L’impresa cooperativa mostra come sia possibile stare dentro il mercato pur non sposando il fine della massimizzazione del profitto. Alcune esperienze realizzate da banche (es. BCC) cooperative (di produzione di beni e servizi) e imprese sociali mostrano come sia possibile e necessario realizzare forme di ibridazione tra non-profit e profit. La cooperazione deve far capire agli imprenditori che il modello capitalistico è ormai obsoleto e non conviene più. Che oggi c’è un modo diverso di fare profitto, che va oltre la moda della responsabilità sociale di impresa e oltre il welfare aziendale, se questo ripercorre il modello del welfare redistributivo e non generativo. Basti guardare alla mondo della natura per rendersi conto che l’ibridazione è fondamentale. Le api passano da un fiore ad un all’altro per raccogliere il nettare.
Le imprese capitalistiche hanno adottato principi e modelli che sono stati inventati dalle cooperative. In Italia, solo nel 1996, è stato istituito il Corso di Master Universitario in Economia della Cooperazione dell’Università di Bologna, di cui sono stato Direttore. Giovanni Berlinguer, allora ministro dell’istruzione, firmò il decreto che prevedeva l’insegnamento sui temi della cooperazione.
6. Alcune recenti scelte politiche, come quella di riforma delle Banca polari, non vanno in direzione opposta? Non le sembra che si rischia di penalizzare una realtà che ha dato un contributo importane all’economia del Paese?
L’esecutivo ha voluto utilizzare un provvedimento di urgenza per imporre alle banche popolari l’obbligo di cambiare natura e identità. Tutto ciò non è accettabile in una democrazia liberale. È tipico di economia pianificata. Il governo può stimolare e incentivare, offrendo la facoltà di scelta. E promuovendo un confronto aperto, nelle assemblee dei soci. A partecipare poi dovrebbero essere persone che hanno un volto e un’anima. Così si distrugge un capitale sociale che ha più di 130 anni. Condivido invece il processo di autoriforma che sta interessando le BCC.
7. Chiudiamo con la riforma del terzo settore, espressione che lei non ama. Lo scorso 9 aprile la Camera ha approvato il Disegno di legge Delega per la riforma del Terzo Settore. L’iter non è ancora concluso ma sembra che ormai siamo in dirittura d’arrivo. Come giudica il testo legislativo? Quali sono a suo avviso i nodi critici presenti e gli elementi di novità più importanti?
La riforma è ferma al Senato. La riforma del terzo settore è sicuramente un passo decisivo in avanti. E’ la più ampia riforma del dopo guerra che presenta una pluralità di contenuti, alcuni dei quali non perimetrabili dentro i confini classici del terzo settore vista l’ampiezza e la portata storica della proposta di riforma. Ne cito solo tre: la valorizzazione del servizio civile in un’ottica di leva per lo sviluppo economico e di scuola di cittadinanza; la definizione più chiara di quali sono i soggetti che fanno le politiche pubbliche e lo snellimento delle procedure burocratiche.
Venendo invece ai nodi critici, segnalo in primo luogo la questione del modo nel quale si vuole concettualizzare l’impresa sociale ossia la necessità di affrontare il tema dell’impatto sociale generato da queste imprese. Una questione che, in parte, è legata anche alla fase di passaggio che il Terzo settore italiano sta attraversando: la transizione da welfare state a welfare society. Su questa questione ci sono due orientamenti, due visioni opposte. Il primo sostiene che l’impresa sociale non può essere misurata. Quindi la riforma del Terzo settore non può imporre dei criteri di misurazione dell’impatto sociale. Il secondo orientamento sostiene invece la necessità di misurare l’impatto sociale con criteri oggettivi anche per consentire ai soggetti di Terzo settore di accedere ai finanziamenti dell’UE.
Occorre che le imprese sociali giochino d’anticipo, proponendo metriche di misurazione dell’impatto sociale che tengano conto della loro identità e specificità. Del resto, la misurazione d’impatto sociale è in linea con le politiche basate sull’evidenza dei dati raccolti attraverso sperimentazioni che si sono affermate a livello internazionale. Cosa intendo per metrica del terzo settore? Ci sono delle dimensioni che si possono misure: la democrazia interna, la partecipazione dei lavoratori, la governance interna, la resilienza. E’ evidente come non si possano utilizzare nella valutazione d’impatto dell’impresa sociale solo parametri di tipo economico. Il criterio di fondo deve essere quello di vedere quanto bene quell’impresa ha generato in un territorio. Ma attenzione. Non bisogna rinchiudersi nella tana, per usare un’immagine cara a Kafka. Questa sfida va colta e per farlo serve un colpo d’ala.
I dubbi, le lamentele e le preoccupazioni degli esponenti del mondo del Terzo settore dovrebbero concentrarsi sui questi punti e chiedere che i decreti delegati contengano un riferimento chiaro, sul tema della valutazione d’impatto, alla quesitone di una metrica che possa adeguatamente misurare e valutare l’azione delle imprese sociali.

 Proponiamo un’intervista a
Proponiamo un’intervista a