Le Acli terranno il loro 54° all’Incontro Nazionale di Studi ad Assisi dal 29 settembre al 1° ottobre. Il titolo di quest’anno è: «Dignità e lavoro, vie per la speranza». Lei ha dedicato al tema della dignità e del lavoro parte della sua ricerca pedagogica. Cosa può dirci? Da amico e compagno di strada delle Acli a suo avviso, cosa le suggerisce questo tema rispetto alle sfide a cui l’associazione deve rispondere?
Oggi si vive la costruzione e la percezione della dignità della persona attraverso i primi rapporti con la realtà del lavoro. Da un lato il lavoro esprime la possibilità di un proprio contributo e la spesa delle proprie capacità e competenze, e una forma di partecipazione con altri alla costruzione di un servizio, un prodotto, una forma di relazione. Ma oggi la realtà del lavoro è fortemente frammentata e per molti giovani fortemente precarizzata ed è come se così frammentassimo e precarizzassimo anche la dignità.
Se entrare nel lavoro vuol dire entrare in condizioni di precarietà, di soggezione, di scarso riconoscimento economico, di forzature molto forti sui tempi di vita; se questo è il messaggio che la società manda alle nuove generazioni siamo di fronte ad una sorta di rinuncia alla speranza.
Eppure, l’esperienza lavorativa non è solo questo. In alcuni territori il lavoro resta un luogo di ricerca, di misura di sé, di costruzione di responsabilità: e questo va valorizzato e sostenuto con forza. Addirittura, in alcuni casi, su questo si può trovare la possibilità di costruire delle alleanze sociali, che in qualche caso possono coinvolgere anche le realtà d’impresa. Tra l’altro non è detto che se l’impresa è cooperativa favorirà per certo tutto questo.
Oggi lo stesso lavoro sociale è fortemente segnato da precarietà, scarso riconoscimento e frammentarietà. Si tratta di provare a ricostruire delle alleanze attorno al lavoro e considerare di nuovo la possibilità di riaprire il lavoro come luogo importante per costruire una storia di vita e di relazioni.
Le Acli, facendo formazione professionale, impresa sociale, essendo presenti nei territori come luogo di pedagogia sociale ma anche di una politica che si costruisce come forma di partecipazione alla vita gli uni degli altri, possono mettere in gioco esperienze e risorse materiali che danno cornice e possibilità alla vita fragile. Le Acli possono creare quantomeno delle oasi di concreta speranza: di sperimentazione di nuovo lavoro e impresa civile. E la generazione adulta e anziana, che ha avuto la fortuna di vivere la stagione dei diritti, può dare un “lascito”. Generazioni anziane e adulte capaci di libertà e di responsabilità nei confronti del futuro di altri, aprono il tempo perché oggi rischia di non riuscire ad entrare nel gioco adulto, in questo momento di passaggio, e di rinunciare alla speranza.
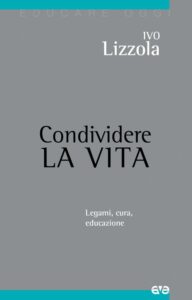 Ha dedicato molto della sua ricerca al tema della cura. Nel suo libro “Condividere la vita. Legami, cura, educazione” (Ave 2018) osserva come è ormai tempo di tornare a pensare la relazione educativa fuori dalla sua forma istituita e strutturata. È tempo di pensare l’educare come tempo dell’incontro. Con due dinamiche – quella dell’affidamento reciproco e quella della rideclinazione della storia di vita – che avvicinano la relazione educativa alla relazione di cura. In che modo questo tema della cura delle relazioni si collega a quello della dignità? La capacità di prendersi cura, ieri come oggi, in che modo più ridare fiducia e speranza alle relazioni personali e collettive?
Ha dedicato molto della sua ricerca al tema della cura. Nel suo libro “Condividere la vita. Legami, cura, educazione” (Ave 2018) osserva come è ormai tempo di tornare a pensare la relazione educativa fuori dalla sua forma istituita e strutturata. È tempo di pensare l’educare come tempo dell’incontro. Con due dinamiche – quella dell’affidamento reciproco e quella della rideclinazione della storia di vita – che avvicinano la relazione educativa alla relazione di cura. In che modo questo tema della cura delle relazioni si collega a quello della dignità? La capacità di prendersi cura, ieri come oggi, in che modo più ridare fiducia e speranza alle relazioni personali e collettive?
Bisogna capirsi bene su cosa intendiamo per relazione di cura. La relazione di cura è una forma della relazione: prendersi cura è incontrarsi assumendo dentro la relazione la dimensione della vita comune. È tessere reciprocità, prossimità, quella nella quale si costruisce la dignità, perché la dignità sta dentro la relazione. È la relazione che crea il riconoscimento reciproco. Ma nelle relazioni di cura c’è sempre un richiamo al gioco delle responsabilità anche da parte di chi è nella condizione di fragilità.
La relazione di cura cambia la simmetria e stabilisce la possibilità di una relazione paradossale: di reciprocità asimmetrica. È come se l’asimmetria e la fragilità chiamassero al gioco di sé. Da questo punto di vista la fragilità è chiamata alla responsabilità, all’offerta, alla attivazione. Non si regge soltanto come destinataria di diritti e di cure.
La cura è anche cura della responsabilità e dà forma ad una responsabilità reciproca, come nell’educazione. È difficile separare chi è educato e chi educa. Nella relazione educativa tutti sono educati ed educatori. Questo è interessante perché è ciò che attiva la dinamica di redenzione e conversione continua della forma di convivenza. Bisogna sviluppare la capacità di vivere la novità, capacità che ridisegna la forma di convivenza. La novità è elemento proprio della relazione educativa e della relazione di cura, come dell’incontro dentro la vita sociale.
Tornando alle Acli che, come forma associativa, sono molto strutturate, credo che corrano un grande rischio: avere già definite le forme del servizio e delle prestazioni da dare credendo che i bisogni possano essere letti, una volta per tutte. Devono riscoprire la capacità di inizio e la condivisione di luoghi di lettura delle condizioni di vita comune. Luoghi che permettono di costruire conoscenza e riposizionamenti e un nuovo gioco di progetti e presenze. Un ridisegno delle relazioni tra noi e soprattutto tra le generazioni.
 Nel suo libro “Vita fragile, vita comune. Incontri con operatori e volontari” (Il Margine 2017) osserva come molte donne e molti uomini sentono oggi di vivere le loro fragilità nei frammenti di una convivenza dai legami incerti. In questo tempo di attraversamento delicato, il lavoro sociale e educativo può permettere di leggere e di coltivare il nuovo che sta nascendo: dalle prossimità, da circuiti di responsabilità, in nuove configurazioni della vita comune. Le forme della vita comunitaria possono essere una risposta alle situazioni di fragilità dando nuova dignità alle persone? Possono offrire una speranza rinnovata? In che senso?
Nel suo libro “Vita fragile, vita comune. Incontri con operatori e volontari” (Il Margine 2017) osserva come molte donne e molti uomini sentono oggi di vivere le loro fragilità nei frammenti di una convivenza dai legami incerti. In questo tempo di attraversamento delicato, il lavoro sociale e educativo può permettere di leggere e di coltivare il nuovo che sta nascendo: dalle prossimità, da circuiti di responsabilità, in nuove configurazioni della vita comune. Le forme della vita comunitaria possono essere una risposta alle situazioni di fragilità dando nuova dignità alle persone? Possono offrire una speranza rinnovata? In che senso?
C’è un grande bisogno di comunità nello sfilacciamento delle relazioni comunitarie e le Acli, e tante forme di esperienza sociale associativa e comunitaria, vedono possibile rilanciare la loro esperienza come tessitura di comunità. È una condivisone che deve essere rilanciata come decisiva nei circoli. Con una attenzione: il rischio di fare di queste comunità delle solidarietà perimetrate e chiuse, identitarie e un po’ difensive, è molto forte; come è forte la tentazione di mostrare l’esemplarità di queste forme comunitarie rispetto al resto della vita sociale.
Le donne e gli uomini che sono capaci di tessere nuovi tessuti di comunità, di convivenza portano dentro di sé anche un po’ di indifferenza, di “disaffiliazione”, di paure e preoccupazioni. Legandosi insieme, grazie alle Acli, possono sostenersi reciprocamente nel mettere in gioco soprattutto la parte generativa delle, loro potenzialità e del loro essere. Bisogna tessere comunità, perché è questo che manca; bisogna fare esperienze di incontro, in cui sperimentare scambi, messe in comune di risorse materiali o di tempo. Scelte molto semplici e concrete di vita quotidiana e di prossimità.
Queste cose molto concrete vanno rilanciate e ritessute. Poi queste esperienze devono “vegliare” su se stesse per non diventare luogo di soddisfazione e di consolazione. Per essere capaci di rinforzare un tessuto più ampio di vicinanza e prossimità che è il tessuto fine della democrazia, quella che permette alla democrazia di non essere un involucro vuoto di regole e di forme.
 Nel libro “Un senso a questi giorni: Conversazione con Pierluigi Mele (Castelvecchi 2020) osserva come l’epidemia abbia travolto le nostre sicurezze e sconvolto le nostre abitudini. La paura si è imposta nella nostra quotidianità, impedendoci di distogliere lo sguardo dalla sofferenza, come eravamo invece abituati a fare soprattutto di fronte al dolore degli emarginati. Abbiamo oggi la possibilità di ripartire abbracciando una nuova prospettiva? In che senso? In che modo è possibile passare dalla paura e dalla rassegnazione alla speranza? Come è possibile attivare nuovi processi, nuove visioni del mondo?
Nel libro “Un senso a questi giorni: Conversazione con Pierluigi Mele (Castelvecchi 2020) osserva come l’epidemia abbia travolto le nostre sicurezze e sconvolto le nostre abitudini. La paura si è imposta nella nostra quotidianità, impedendoci di distogliere lo sguardo dalla sofferenza, come eravamo invece abituati a fare soprattutto di fronte al dolore degli emarginati. Abbiamo oggi la possibilità di ripartire abbracciando una nuova prospettiva? In che senso? In che modo è possibile passare dalla paura e dalla rassegnazione alla speranza? Come è possibile attivare nuovi processi, nuove visioni del mondo?
Ricordo la lezione di un grande filosofo Hans Jonas autore de Il principio responsabilità in cui sostiene l’importanza di scoprire il buon uso della paura. Perché quando dici di passare dalla paura alla speranza dici una cosa un po’ rischiosa. Noi avremo sempre a che fare con la paura; come è possibile far nascere la speranza dentro l’esperienza della paura? È possibile? Sì. La paura non ci lascerà mai, però una paura condivisa e la forza che può nascere dalla condivisione e dalla corresponsabilità può aprire alla speranza, Non è paura contro speranza ma è una speranza che può nascere da dentro considerazioni che non negano la drammaticità della vita proprio perché la incontrano e la guardano negli occhi.
Se gli uomini si legano tra loro e condividono possono essere aiutati ad attraversare il timore e questo attraversamento si chiama costruzione concreta della speranza di vita. Un andare oltre la paura prima che questa ci attanagli.
Il contrario della speranza è l’angoscia, non la paura. La paura può aprire: abbiamo tutti paura di alterare definitivamente l’equilibrio della biosfera, e che la violenza si affermi in grandi strutture come la guerra. Ci sono paure positive che potrebbero portarci a un legame per tenere aperto il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti; il desiderio di vita. Questo è il senso dei nostri giorni, che non sono solo “nostri” ma sono il luogo concreto per rendere possibile il futuro di altri.
 E veniamo al suo ultimo libro “Aver cura della vita. Dialoghi a scuola sul vivere e sul morire” (Castelvecchi 2021). Si parte da una domanda. Di quale parola, di quale ascolto può farsi capace la scuola di fronte all’esperienza del soffrire e del morire? Una parola che non voglia spiegare né risolvere ma sappia custodire domanda, singolarità, cura e dedizione. In che modo la scuola, soprattutto dopo l’esperienza pandemica, può diventare comunità di ricerca e comunità di senso. L’avere cura delle sofferenze dei giovani, il parlare loro del vivere e del morire quale valore ha oggi? Ed ancora il parlare di dignità, lavoro e speranza alle nuove generazioni che connotazioni dovrebbe assumere?
E veniamo al suo ultimo libro “Aver cura della vita. Dialoghi a scuola sul vivere e sul morire” (Castelvecchi 2021). Si parte da una domanda. Di quale parola, di quale ascolto può farsi capace la scuola di fronte all’esperienza del soffrire e del morire? Una parola che non voglia spiegare né risolvere ma sappia custodire domanda, singolarità, cura e dedizione. In che modo la scuola, soprattutto dopo l’esperienza pandemica, può diventare comunità di ricerca e comunità di senso. L’avere cura delle sofferenze dei giovani, il parlare loro del vivere e del morire quale valore ha oggi? Ed ancora il parlare di dignità, lavoro e speranza alle nuove generazioni che connotazioni dovrebbe assumere?
Farei due riflessioni. La prima: è possibile fare ancora scuola durante la pandemia e la guerra se non come esperienza di incontro tra generazioni che provano a costruire un senso della memoria, del lascito ricevuto, dai sogni e dalle saggezze delle generazioni precedenti, e un rapporto con il tempo da aprire. È possibile che la scuola non sia una esperienza di queste cose? in cui si ospitano i vissuti, la ricerca di vita che si fa da dentro ogni vita di un giovane che cresce?
Da qui le domande importanti attorno al “cosa possiamo credere?”, e poi attorno al “cosa è importante che capiamo?”
La scuola è un incontro tra credenti nella vita, ragazzi ed adulti che cercano il sapere e la possibilità di progettare e rendere bella la vita comune. E quindi le economie possibili, gli scambi culturali possibili, le scienze e le tecniche possibili: scegliendo tra i possibili quelli che coltivano e generano salvaguardia e vita futura. La scuola è questo o non è.
La seconda riflessione riguarda la dignità, il lavoro, la speranza delle nuove generazioni. Facciamo questa intervista due giorni dopo la morte di un altro ragazzo che era in alternanza scuola-lavoro: e questo non è possibile. I ragazzi che muoiono in alternanza scuola-lavoro, o durante i tirocini stanno vivendo il lavoro nella nuova incertezza, nella nuova durezza, nella trascuratezza della salvaguardia delle vite delle persone. Questo ha portato all’aumento degli incidenti e delle morti sul lavoro.
Quando un giovane che studia incontra il lavoro non deve incontrarlo nella forma dell’adattamento al lavoro che c’è: rischia di morirci se non entra in una azienda che fa sul serio un lavoro sulla sicurezza. L’alternanza serve perché la scuola entri e provochi il lavoro, le organizzazioni del lavoro, il diritto del lavoro, a ripensarsi a partire dai percorsi e dalle ricerche che dentro quel lavoro fanno gli studenti in cerca di vita e di sapere, accompagnati dai loro insegnanti.
Non si entra per adattamento ma in qualche modo provocando delle revisioni, delle ricerche.
La scuola può entrare nelle realtà del lavoro per renderle migliori. Invece non è così.
Se la scuola va nelle realtà del lavoro per far vedere a cosa si dovranno adattare gli studenti; considera il lavoro com’è, come realtà che è davanti e la scuola indietro. In rimorsa. Ma non deve essere così. La scuola ospita delle immaginazioni, degli scenari del diritto, dei desideri di valore e di futuro, è nel futuro, avanti. A partire da questo deve incontrare le realtà lavorative: provocandole, riempiendole di istanze di ricerca e di nuove aperture perché le realtà del lavoro cambino.
Tags: dignità INS2022 Lavoro speranza





