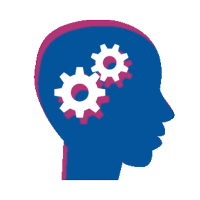Stella Morra insegna teologia alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificia Ateneo Sant’alselmo, è vicepresidente del Coordinamento delle Teologhe italiane e sociologa. La multidisciplinarietà che attraversa il suo percorso di riflessione, la fede che la anima e l’esperienza ecclesiale, la aiutano ad avere uno sguardo più profondo sulle mutazioni epocali che la chiesa sta attraversando.
Stella Morra insegna teologia alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificia Ateneo Sant’alselmo, è vicepresidente del Coordinamento delle Teologhe italiane e sociologa. La multidisciplinarietà che attraversa il suo percorso di riflessione, la fede che la anima e l’esperienza ecclesiale, la aiutano ad avere uno sguardo più profondo sulle mutazioni epocali che la chiesa sta attraversando.
Il libro è denso per la materia che tratta, cui non siamo molto abituati, ma chiaro e con l’intenzione di accompagnare il lettore in un cammino di conversione di pensieri che ci impediscono di vivere con serenità il trapasso ecclesiale iniziato con il Concilio Vaticano II e che stiamo vivendo ancora oggi.
L’invito a leggerlo che faccio nasce proprio dal sentimento che piano piano si è fatto avanti in me leggendo quello che considero uno dei libri più interessanti e stimolanti che ho letto negli ultimi anni: un sentimento di liberazione, di allargamento del cuore e di richiesta di impegno per il tempo dell’oggi.
Il punto focale è la trasformazione della forma della chiesa e quindi dell’esperienza di fede e della sua possibilità di essere vissuta e detta nel tempo-spazio che abitiamo.
Tutto il testo è punteggiato da esempi di come abbiamo detto e vissuto fino ad oggi la forma ecclesiale e di come potremmo iniziare a sperimentarla e quindi a dirla da adesso in poi. La tesi di fondo è che stiamo passando dalla forma gregoriana-tridentina-tomista alla forma misericordiosa.
Stella Morra non vuole definire cosa è la misericordia, ma proporre un programma di lavoro per i prossimi decenni: «Per prima cosa bisogna ricostruire la rete tra forma, materia e ministro della misericordia e farli crescere insieme. In secondo luogo occorre chiedersi quale sia il processo che la misericordia instaura» (p. 135). Appena prima precisa che «la materia su cui si esercita la misericordia è decisamente la vita» e che «la tradizione insegna che si è ministri perché si prende la parola» (p. 134).
Rimane la questione della forma «secondo la quale noi facciamo agli altri ciò che Dio ha fatto a noi […] Con una risposta estremamente sintetica potremmo rispondere che si è messo dalla nostra parte, ha assunto l’umanità e lo ha fatto al massimo grado della croce» (p. 135), cioè ha vissuto il mistero pasquale di passione, morte e resurrezione, come segno della misericordia di Dio: «Dio non ci umilia aiutandoci, ma si umilia salvandoci» (p. 136).
Stella Morra propone la misericordia come categoria generatrice della nuova forma che sta prendendo la chiesa.
Lo fa con una disanima precisa e sintetica delle varie difficoltà delle forme che la chiesa ha assunto e vissuto nella sua storia fino ad ora (capitolo secondo).
Affronta in particolare la forma tomista che ci accompagnato per molti secoli e ne mostra le ricchezze ma anche i limiti (capitolo terzo), e qui sta la conversione più vera del nostro dire e vivere la fede, conscio e inconscio. Sono molte le parole e i discorsi che ci facciamo come comunità ecclesiale, ma che tradiscono, spesso, un non discernimento e una non riflessività critica delle categorie che usiamo e soprattutto degli schemi mentali che usiamo quotidianamente per cercare di dialogare tra noi. Questa non riflessività critica implica cortocircuiti non solo a livello del pensiero, ma soprattutto a livello di esistenze vissute.
Il tempo di passaggio che stiamo attraversando richiede, attingendo alla modalità con cui altre crisi dei primi secoli sono state affrontate (Nicea e Calcedonia, per esempio), di poter trovare «una forma di vita cristiana “senza confusione e senza separazione”, una vita non dominata dalla genericità o dall’esclusione, ma visibile e abitabile» (p. 48). Qui l’autrice si impegna a una disamina di tre nodi fondamentali: la cattolicità, l’inclusività e la processualità, mostrando risposte facili ma inutili e proponendo alcuni criteri di fedeltà evangelica che il Concilio Vaticano II ha riproposto in forma narrativa e non giuridica, a partire dalla sottomissione alla parola di Dio dataci come grazia (capitolo quarto): «Per questo motivo i cristiani non presumono (non dovrebbero presumere) di poter spiegare teoricamente tutto e di avere una buona risposta per ogni questione, ma si allenano (si dovrebbero allenare) a riconoscere l’evangelo dove accade, diventando messaggeri di buone notizie» (p. 54).
Nel capitolo quinto Stella Morra si preoccupa di mostrare le differenze tra la forma che sta passando e quella che si sta affacciando rispetto a temi caldi: rapporto tra ortodossia e ortoprassi, rapporto tra vita e natura, principio dell’autorità, sottovalutazione della pratica, il tentativo della nuova evangelizzazione, troppa appartenenza e poca identità, la crisi della spiritualità, proponendo di tornare a considerare la vita secondo lo Spirito come un criterio e non come un contenuto.
Occorre una nuova epistemologia (capitolo sesto) che la teologa qualifica come “epistemologia della complessità. Capitolo denso che ripropone vari snodi concettuali e che merita di essere letto con attenzione, quasi meditato, per poterne cogliere fino in fondo il potere di liberare energie fresche per il nostro vivere nel mondo.
L’ultimo capitolo si misura con l’esperienza della misericordia di Dio mostrandone tutti i vantaggi che si acquistano se la consideriamo come categoria generatrice. Dapprima mostra sette dimensioni della misericordia nel suo valore performativo, che realizza ciò che dice, poi riprende i nn. 217-237 della Evangelii Gaudium di papa Francesco, mettendo così alla prova della pastoralità del vescovo di Roma le dimensioni precedentemente esplorate.
Il dolce in fondo, a conclusione di un pasto prelibato e succulento, che presenta vari sapori, antichi e nuovi, in una miscela che rende conto di una globalizzazione ecclesiale che avanza e di cui non dobbiamo avere paura, ma abituarci ad assaporare come dono dello Spirito che avanza nella storia per realizzare la parola di Dio.
Stella Morra, Dio non si stanca. La misericordia come forma ecclesiale, EDB, Bologna 2015.
Citazioni
“Per cogliere il segno di Dio nella realtà occorrono vigilanza e silenzio. […] La misura deve essere quella del più povero” (pp. 126.128).
“Dovessi elaborare una graduatoria dei pericoli per la fede, penso che la progressiva individualizzazione avrebbe il primo posto: sta rischiando di uccidere l’esperienza cattolica del cri-stianesimo, è uno dei meccanismi che sta veramente interrompendo la tradizione, che ci sta impedendo di mostrare il cristianesimo come evento di benedizione. La sua radice più profonda è nel sovraccarico di coscienza del singolo credente, che non solo non è una salvezza e una benedizione per i nostri contemporanei, ma sembra essere l’ennesimo impegno di un’agenda già molto piena” (p. 28).
“Una buona volontà senza una competenza nel momento di crisi può produrre un grande caos. Più o meno, è quello che è successo dal Vaticano II a oggi” (p. 29).
“Papa Francesco, semplicemente, si muove come uno che ha piena consapevolezza che quell’idea di sacralità del primato petrino non esiste più. Non è lui che ha fatto finire quell’impianto, è semplicemente uno che si muove smettendo di far finta che esista ancora” (p. 33).
“La difficoltà più grande per un teologo – che di per sé lavora con i concetti, le idee, le parole – risiede nel fatto che il cristianesimo non si basa su un’idea, ma sull’esperienza di un fatto. Si basa cioè sull’esperienza di Dio che diventa carne in Gesù Cristo (cfr. Gv 1)" (p. 37).
“La struttura di Tommaso, infatti, funziona benissimo per affrontare la vita nella sua realtà, ma ha un limite evidente quando si tratta di leggere un altro livello dell’esperienza di fede, che è quello simbolico-rituale” (p. 41).
“Un esempio chiaro è l’uso che si fa tuttora della categoria di natura. Per Tommaso è di tipo inclusivo: la usa per dire ciò che tutti possono riconoscere e su cui tutti possono concordare, compresi musulmani e giudei (il pluralismo che aveva intorno). In questo contesto, natura è legato l tema della ratio, della ragione riconoscibile da tutti. Tommaso la usa per «de-confessionalizzare». Noi siamo invece all’estremo opposto della parabola: natura è diventato il tema identitario, esclusivo, radicale, per distinguere chi è cattolico e chi no” (p. 43).
“Non si può mettere mano alla forma senza coinvolgere anche la sostanza. Il problema tuttavia è un altro: se si accetta il dato della processualità, non tutti i cambiamenti sono tradimenti. Sono cambiamenti anche di sostanza, ma non dei tradimenti” (p. 45).
“Senza adeguate contromisure, fissare – non tanto o non solo nella teoria accademica, quanto nelle pratiche concrete – l’ortoprassi come criterio della fedeltà evangelica significa svuotare le fila della Chiesa: dal momento che siamo tutti peccatori, chi può fare affidamento sulla sua condotta per giustificare la fedeltà al Vangelo? […] L’esito peggiore è agire a partire dalla presunzione – anche solo implicita – che la salvezza sia data dall’assenza di peccato e non dalla carità” (p. 56).
“Se il vangelo deve essere annunciato, non può essere autoevidente” (p. 59).
“La conformazione a Cristo richiede la soggettività del singolo: è quindi un fatto personale, ma non è mai un fatto individuale” (p. 63).
“L’appartenenza fa infatti della regola il fine. E’ orizzontale, sottolinea la conformità alla regola che ci si è data, mentre l’identità sottolinea la conformità all’obiettivo per cui la regola esiste. Nella logica dell’identità la regola è uno strumento, per quanto prezioso lo spossa considerare” (p. 65).
“Vorrei essere molto chiara: sono convinta che in un tempo di transizione come il nostro sia necessaria più teoria, perché ci sono molte variabili da tenere in considerazione e meno parole di quante ne avremmo bisogno. Deve essere tuttavia una teoria molto nutrita dalla pratica, quindi molto capace di guardare la realtà e di riconoscerla operando un esercizio critico sull’esperienza” (p. 67).
“L’attenzione esasperata ai principi ha comportato nella teologia la perdita di qualcosa di più grande. L’esempio più evidente di questo processo di riduzione è la sostituzione di fatto – nella vita credente – del racconto biblico con i contenuti del catechismo. Per quasi cinque secoli «imparare la dottrina» è stato molto più importante che «ascoltare il vangelo»” (p. 73).
“La forma del racconto è la forma congeniale all’autorivelarsi di Dio nella storia. Sostituisco al racconto un principio – sia esso quello di autorità o di dottrina – inevitabilmente opero una riduzione” (p. 74).
“Detto in altre parole, abbiamo bisognoso una forma della fede che mostri in se stessa lo spossessamento” (p. 78).
“L’esagerazione della causalità ci ha fatto perdere di vista la logica dell’incarnazione, che però – le vie del sensus fidei sono infinite – si ritrova ancora in molti ragionamenti dell’esperienza credente. Oggi nessuno crede perché è certo che Dio sia la causa del mondo. L nostra esperienza di fede muove da un’altra intuizione originaria: crediamo perché abbiamo sperimentato misericordia. […] La radice della fede non ha nulla a che fare con la logica della causalità, ma al contrario è spesso una misericordia senza causa, ed esattamente in questo sta la sua esplosività, lo stupore” (pp. 91-92).
“Uno dei nostri problemi era aver ridotto l’esperienza cristiana a un oggetto staccandola dal soggetto. L’epistemologia della complessità conferma che questa separazione non corrisponde al reale e ci offre elementi per ripensare la fede” (p. 92).
“Dobbiamo smettere di pensare che il nostro compito come teologi sia solo quello di spiegare un oggetto, già dato e descritto una volta per sempre, per tornare ad ascoltare quello che succede e dare parola al sensus fidei facendo dialogare il rigore delle conoscenze e del principio critico della ragione con le azioni e le emozioni e i pensieri di tutto il popolo di Dio” (p. 99).
“Detto in altro modo, diventare un popolo è molto più che essere cittadini titolari di diritti e doveri” (p. 110).
“Per passare da cittadini a popolo non è sufficiente condividere uno status, ma occorre un consenso intorno a una cultura, cioè riconoscersi in una sovrabbonda simbolica. Se il punto di consenso fosse un’uniformità costruita intorno a un concetto esatto, l’esito più probabile sarebbe il totalitarismo. Bisogna diventare un popolo con un consenso simbolico, quindi non dimenticare che il tempo è sempre superiore allo spazio” (pp. 113-114).
“Se invece il tempo è superiore allo spazio, la vera questione è privilegiare la potenza di promessa di ogni gesto della vita […] Radicandolo invece sulla categoria della promessa, il peccato potrebbe essere spiegato come la mancanza di riconoscimento della promessa che la vita è, o meglio, che ogni gesto di vita è. Si potrebbe dire che il peccato è rimanere al di sotto della soglia della propria felicità possibile e promessa” (p. 116).
“Dio perdona i nostri peccati perché ci guarda rendendosi bisognoso di noi e chiamando in vita tutto quel di più di noi che noi stessi non sappiamo nemmeno di possedere, e che non ci potremo dare da soli. Organizzare la propria vita, impostarla, sceglierla su questa logica sulla certezza che lo sguardo amoroso di Dio chiamerà in vita tutti i pezzi di me che io non so di avere, è forse una definizione possibile di «essere cristiani» secondo la forma della misericordia” (p. 117).
“Come accadde ai discepoli, si sta al fianco di Gesù capendo e anche non capendo. La questione è il popolo fedele, non il popolo intelligente” (p. 118).
“La sfida enorme è di tramutare questo principio in una pratica in grado di comprendere la parzialità senza subordinarla gerarchicamente alla pienezza che non c’è ancora” (p. 119).
“Concentrandosi ognuno sul proprio spazio, risultato, scopo e non sulla promessa si va al conflitto” (p. 121).
“L’unità è il frutto di una solidarietà, non si dà in riferimento a un criterio oggettivo, ma nella costruzione di una storia, nella «risoluzione su un piano superiore che conserva in sé le preziose potenzialità delle polarità in contrasto»” (p. 122).