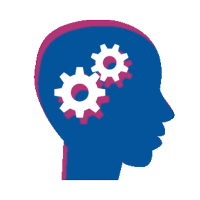Francesco Munzi è tra i nomi più interessanti dell’ultima generazione del cinema italiano. Nato a Roma nel 1969, si è iscritto al Centro Sperimentale di Cinematografia, dove si è diplomato in regia, e, dopo alcuni cortometraggi, ha esordito nel 2004 con Saimir, presentato nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia. Quattro anni dopo ha diretto Il resto della notte (2008), in cartellone alla Quinzaine des Realizateurs del Festival di Cannes. Il suo terzo film, Anime nere, è del 2014 ed è stato proposto nel cartellone ufficiale del Concorso alla 71^ edizione della Mostra di Venezia 2014.
Francesco Munzi è tra i nomi più interessanti dell’ultima generazione del cinema italiano. Nato a Roma nel 1969, si è iscritto al Centro Sperimentale di Cinematografia, dove si è diplomato in regia, e, dopo alcuni cortometraggi, ha esordito nel 2004 con Saimir, presentato nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia. Quattro anni dopo ha diretto Il resto della notte (2008), in cartellone alla Quinzaine des Realizateurs del Festival di Cannes. Il suo terzo film, Anime nere, è del 2014 ed è stato proposto nel cartellone ufficiale del Concorso alla 71^ edizione della Mostra di Venezia 2014.
Munzi si rivela autore in grado di affrontare in maniera diretta e incisiva i temi più delicati della nostra contemporaneità, senza rinunciare a vederne gli aspetti etici e morali. Da queste premesse nasce Anime nere, che parla in maniera esplicita e assoluta del fenomeno della “mafia”.
Il racconto comincia ai giorni nostri. Si parte dall’ Olanda, si passa a Milano, si arriva sulle vette dell’Aspromonte. Lungo questo percorso si muovono tre fratelli, figli di pastori, vicini alla ‘ndrangheta. Luigi, il più giovane, è un trafficante internazionale di droga; Rocco, milanese adottivo, fa l’imprenditore grazie ai soldi sporchi del primo; Luciano, il più anziano, è appartato e pieno di dubbi sulla vita che tutti conducono. Suo figlio Leo, venti anni, conserva su di sé rancore, rabbia, voglia di farsi giustizia da solo. Per un futile motivo, compie un atto intimidatorio contro il proprietario di un bar protetto da un clan rivale. Sembra poca cosa ma è la scintilla che fa divampare l’incendio. Luigi e Rocco finiscono ammazzati. Luciano, esasperato, uccide Leo e, forse, metterà fine anche alla propria vita.
Essendo la materia narrativa molto stratificata e densa di precisi e non a tutti evidenti punti di riferimento, è opportuno ascoltare la voce del regista. “Ho girato il film nel paese che la letteratura giudiziaria e giornalistica stigmatizza come uno dei luoghi più mafiosi d’Italia, uno dei centri nevralgici della n’drangheta calabrese: Africo. Quando raccontavo che avrei voluto girare lì, tutti mi dissuadevano dal farlo: troppo difficile la materia, troppo inaccessibile, troppo pericoloso.
Era un film impossibile. Ho chiesto allo scrittore del libro omonimo da cui il film è tratto, Gioacchino Criaco, di aiutarmi. Sono arrivato in Calabria carico di pregiudizi e di paure. Ho scoperto una realtà molto complessa e variegata. Ho visto la diffidenza tramutarsi in curiosità e le case aprirsi a noi. Ho mescolato i miei attori con gli africesi, che hanno recitato, lavorato con la troupe. Senza di loro credo che il film sarebbe stato più povero. Africo ha una storia di criminalità molto dura che però può aiutare a comprendere tante cose del nostro Paese. Da Africo si può vedere meglio l’Italia”.
Un film incentrato dunque sulla ricostruzione di una realtà totalmente negativa e autodistruttiva acquista senso solo di fronte ad una forte capacità di sintesi, di concretezza, di riduzione a metafora dell’assunto narrativo. Fatta la scelta di un copione delicato e difficile al limite dell’ambiguità descrittiva, era difficile mantenersi sulla scia di lontani, ancorché nobili precedenti, quali In nome della legge di Pietro Germi (1950) o “Il giorno della civetta” di Damiano Damiani (1969).
La prospettiva è qui più interiore, calata nelle viscere di una sedimentazione secolare che non la smette di attanagliare anche i giovani e che crea squilibri di coscienza in coloro che non intravedono vie d’uscita. Al momento della messa in scena, ossia del passaggio alle immagini, Munzi rivela polso fermo e robuste doti visive nel raccontare fatti che dalla finzione iniziale si piegano sulla realtà e provano nel finale a tornare all’idea di una criminalità intesa come “male” universale, come condanna ancestrale e primigenia, quasi impossibile da cancellare se non nell’ottica di una palingenesi totale e crudele.
In questo mondo a parte, atterrito dalla propria violenza, impaurito dal fare scelte che significano rovesciamento e sovvertimento di abitudini radicate e consolidate, lo sguardo del regista non può emettere sentenze. Se ne tiene lontano infatti Munzi, e il suo finale ci lascia sospesi e incerti su quale Italia si possa vedere meglio da quell’osservatorio. Il film trasmette comunque una forte e accesa dialettica drammaturgica, che lo può veicolare in modo opportuno per dibattiti e riflessioni.