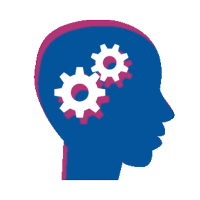«Ben lontana dall’essere alternativa alla misericordia o all’amore, la potenza di Dio è presentata dalle Sacre Scritture come radice di bontà, compassione e carità. La misericordia è la corona e lo splendore della possanza del Signore. Conseguentemente, la cattiveria e le ingiustizie umane non sono sintomi di generico egoismo, ma certificazione di triste impotenza» (p. 15).
Un libro originale nel panorama della riflessione sul potere di Dio e dell’uomo: «Al Dio possente nel creare e salvare corrisponde un uomo che, grazie alla fede, non può che essere potente» (p. 37).
Pagazzi è sacerdote della diocesi di Lodi, docente di teologia alla Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale e ora anche al Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II dopo il suo rinnovamento voluto da papa Francesco, oltre a vari altri insegnamenti, tra cui quello di Estetica del sacro presso l’Accademia delle Belle Arti di Brera, a Milano.
Da anni sta sviluppando una fenomenologia di Gesù che risulta sempre utile e proficuo frequentare per la ricchezza delle riflessioni teologiche, bibliche, antropologiche ed etiche, come si può cogliere anche in questo suo arguto scritto, ironico a volte, sapiente in ogni caso. Un testo che coinvolge e che va soprattutto meditato e riletto più volte, perché affronta una questione fondamentale: «Ecco quindi il compito dell’etica: indicare come un corpo possa stare all’altezza della propria potenza. Lo spunto non è quindi: «Come collimare con il proprio dovere?» (tale domanda è legittima, ma derivata e quindi successiva), bensì: «Come corrispondere al proprio potere?» (p. 73).
L’autore vuole togliere il cristiano, ma anche qualunque uomo – aggiungo io –, dall’imbarazzo di fronte alla questione del potere, pensato quasi sempre come qualcosa di cattivo, opprimente, ecc. Pagazzi mostra come: «Esercitato come tale, il potere è sempre etico, incessantemente giusto. L’ingiustizia prende il suo posto, deformandolo in prepotenza, quando non si vuole stare all’altezza del dovere richiesto dal potere stesso: “Siano gli altri e le altre cose!”» (p. 85).
Il libro si dispiega in tre densi capitoli:
– Quale Dio è come te? Qui si mostra come la potenza-onnipotenza di Dio sia il fondamento della sua compassione attraverso una sapiente ed illuminate lettura del testo biblico da tenere sempre sul comodino prima di addormentarsi.
– Potere, volere, dovere. Pagazzi riprende con novità di intelligenza la lezione di Spinoza, mostrando – dal punto di vista filosofico e antropologico – come il potere fonda il volere e il dovere. Il potere non è solo impeto, ma anche resistenza. Soprattutto, il potere è generare al potere: «Se è vero che nel potere vibra il dovere: “Siano gli altri e le altre cose?”, la forma radicale della possanza è “generare”» (p. 85). Riflessioni veramente utili al pensiero della generatività così presente nel discorso attuale, almeno in certi ambiti.
– Ma se arriva uno più forte… E’ una fenomenologia del rapporto di Gesù con il potere che il Padre gli ha dato: generare la vita. Così anche noi possiamo diventare figli che possono generare alla vita.
«Generare è la forma sovrabbondante della possanza, poiché il potere si configura come donare potere. Dando la vita al figlio, un uomo e una donna lo rendono fin da subito soggetto del verbo potere, già a partire dal poter emettere il primo grido, inspirare la prima aria, piangere, alimentarsi, sentire, addormentarsi e risvegliarsi, via via muoversi nel mondo, lasciandosi motivare e commuovere da esso, prendere, apprendere, comprendere, intraprendere, sorprendere e lasciarsi sorprendere, compiendo queste azioni nella pienezza del potere, e quindi secondo quella giustizia che genera a sua volta potere altrui, oppure con prepotenza, svilendo e disonorando il primo dono ricevuto» (p. 86).
Vi lascio all’invito alla lettura sperando di avervi stuzzicato un poco, così da arrivare in fondo a queste poche pagine e poi giungere a leggere e meditare questo originale e fondamentale libro per ogni cristiano, ma anche per ogni uomo che voglia essere all’altezza del potere che gli è dato di dare vita.
Giovanni Cesare Pagazzi, Tua è la potenza. Fidarsi della forza di Cristo, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2019.
Citazioni

“Tutti sono alla ricerca del potere, essendo la vita il risultato di un fascio di poteri: poter respirare, potersi muovere, potersi nutrire, poter pensare… Ci si trova nel potere di vivere, accorgendoci che non è a portata di mano d’uomo. Perciò tutti inseguono quanto o chi garantisce ciò che è necessario, e tuttavia non a disposizione. Lavoro vitale e faticoso, poiché — san Cristoforo insegna — è facilissimo sbagliare mira, puntando l’affetto e la volontà su cose, situazioni, persone non all’altezza del giusto desiderio di potere” (p. 15).
“Se quella del potere è questione antropologica e teologica decisiva, risulta necessario, per apprezzare la qualità della fede, non solo il criterio del “dovere” più o meno onorato, ma anche quello del “potere” effettivamente ricevuto e preservato grazie alla relazione con Cristo, giacché «senza di lui non possiamo far nulla» (Gv 15 ,5). Si crede davvero, se la fede non dà, restituisce e custodisce poteri?” (p.15).
“Rispondendo alle parole di Elisabetta, Maria canta il proprio inno di lode al Signore, esaltandolo come «il potente» [hò dynatos] (Lc 1,49). Si avverte una sfumatura provocatoria: Dio non è solo «uno potente» e nemmeno semplicemente «potentissimo», ma «il potente», l’esclusivo detentore della possanza. Tale sfumatura diventa asserzione chiara e tonda subito dopo, quando Maria confessa che con «la potenza del suo braccio» (Lc 1,51) Dio «ha rovesciato i potenti dai troni» (Lc 1,52): perfino i potenti non reggono davanti «al potente» “ (p. 20).
“Insomma: non Gesù vinse la morte, ma fu il suo stile buono a superarla, dato che, dopo duemila anni, tuttora il suo comportamento è riconosciuto come ammirevole e impareggiabile. Il risultato è piuttosto evidente: sconfessando la potenza di Dio, prima o poi si è inclini a negare la sua effettiva capacità di risuscitare dai morti il suo Cristo” (pp.29-30).
“Nei due fuochi del “Credo” d’Israele, quindi, vibra la potenza di YHWH, anzi ne è la scintilla. Fosse stato impotente, non avrebbe liberato Israele dall’Egitto, né avrebbe creato il cielo e la terra, sedendosi regalmente sull’abisso. La potenza è a tal punto originaria dotazione e prerogativa di Dio da equivalere al suo stesso nome, tanto da divenirne sinonimo (Ger 16,21)” (p. 32).
“Significando «potente», «forte», geber era termine adatto a indicare «uomo maschio». Tuttavia, la sua frequente associazione alla pratica della fede indusse ad attribuire spesso a geber il senso di «uomo fedele e giusto», come se, inequivocabile, prima caratteristica del credente fosse la potenza, mentre, al contrario, sinistro marchio dell’empio fosse la mancanza di forza, la fiacchezza. Non solo: l’equivalenza di “potente” e “uomo” segnala che un’umanità realmente riuscita e compiuta — davvero a immagine e somiglianza della Potenza — non può che essere potente” (p. 35).
“Due sono le ragioni dell’indulgenza, della compassione e della conseguente moderazione riservata agli egiziani. Innanzitutto, l’onnipotenza stessa: Dio non è compassionevole e misericordioso anche se onnipotente, ma proprio perché è onnipotente: «hai compassione di tutti, perché tutto puoi» (Sap 11,23). Infatti, la sua infinita possanza gli consente il lusso di aspettare i tempi della conversione dei malvagi, pieno di speranza. Sicché l’impazienza, ben lungi dall’essere sintomo di forza irruente, è al contrario segnale inequivocabile di impotenza: non si ha l’energia sufficiente per attendere e sperare. Compassione e misericordia non sono quindi correttivi per l’onnipotenza, ma anzi ne rappresentano la manifestazione compiuta. Considerarle alternative e concorrenti comporta sbagliare il bersaglio del loro mistero” (p. 46).
“Insomma: Dio è affettuosamente vincolato a quanto ha posto in essere. Perciò la sua è una potenza che genera legami dei quali accetta le conseguenze, come l’indulgenza, la compassione, la misericordia e la moderazione. La sua onnipotenza creatrice lo apparenta a tal punto a tutte le cose da non uccidere né Behemot né Leviatan, direbbe Giobbe, e da aver riguardo addirittura per gli egiziani, poiché sono «suoi»” (p. 47).
“L’ingiustizia appare incompatibile con la forza divina: proprio perché potente, Dio è giusto. Infatti, l’ingiustizia è amara conseguenza della paura che spinge ad attaccare o a difendersi a oltranza. È per paura del futuro che si diventa avari in ogni cosa, accumulando e rubando; è per paura che il superbo s’innalza, abbassando gli altri. E per paura di non essere all’altezza che si prova invidia. Stando così le cose, gli uomini ingiusti non sarebbero genericamente scorretti, ma innanzitutto impotenti e perciò esposti all’inganno della paura che inclina verso l’iniquità. Dal veleno della paura è immune chi, tutto potendo, nulla teme e, nulla temendo, è libero da ogni ingiustizia:
Consideri incompatibile con la tua potenza
condannare chi non merita il castigo.
La tua forza infatti è il principio della giustizia
e il fatto che sei padrone di tutti, ti rende indulgente con tutti.
Mostri la tua forza
quando non si crede nella pienezza del tuo potere
e rigetti l’insolenza di coloro che pur la conoscono.
Padrone della forza, tu giudichi con mitezza
e ci governi con molta indulgenza,
perché, quando vuoi, tu eserciti il potere (Sap 12,15-18)
Affidarsi a uno che può tutto significa divenire potenti (geber), mettendosi al riparo dalle insidie della paura, predisponendosi ad agire secondo giustizia. Se l’onnipotenza affettuosa è la condizione di tutte queste caratteristiche di Dio, negarla comporta sconfessare la sua mitezza, la sua indulgenza, la sua giustizia e il suo amore, capace di stimare ogni cosa con speranza. Giustizia, misericordia, amore sono effetti e forme di quella possanza alla quale nulla è troppo difficile, nemmeno allargare in modo insperato e inimmaginabile i confini di quanto normalmente si ritiene possibile” (pp. 47-48).
“Certo, senza questo Respiro la carne non giova a nulla, eppure l’unico desiderio di questo Respiro definitivo è stare con la carne. Altro non vuole e a nient’altro tende se non rendere nuova, definitiva, potente la carne. La gloria della carne è il desiderio dello Spirito di entrare per sempre in essa con la sua invincibile potenza. La gloria dello Spirito è dar vita a quanto è inerte, o vivo solo per un attimo, un soffio. «Cuore di carne» e «Ruah nuova» non sono opposti, ma paralleli, corrispondenti”; sicché agire da esseri “spirituali” significa stare all’altezza della carne a cui lo Spirito desidera togliere ogni sclerosi e insensibilità (morte compresa!)” (p. 61).
“Eppure, la decisione (volere) di prendere il treno e recarsi al lavoro (dovere) diventa effettiva solo a partire da un fascio di poteri, per nulla scontati: posso svegliarmi, alzarmi dal letto, posso lavarmi e vestirmi, sedermi e far colazione, posso preparare il caffè e alzare la tazza alla bocca, posso riordinare la cucina, posso uscire, camminare, posso salire le scalette del treno, e così via… Per spiegare la volontà di compiere il più semplice dovere, dovrei scrivere una lunga lista di poteri. Sicché, se è vero che senza “volere” non si darebbe “dovere” umano, è altrettanto vero che senza “potere” non si darebbero né l’uno né l’altro. Ciascuno dei tre verbi modali non sta senza gli altri, tuttavia la loro posizione non è indifferente. Infatti, all’inizio sta “potere” che, a seconda della mia libera decisione, prende forma divenendo un compito” (p. 69).
“Che “potere” sia la radice su cui crescono “volere” e “dovere” lo dice anche il fatto che mi trovo — senza sapere come — nella condizione di poter fare qualcosa. Prima che io voglia o ci rifletta, mi trovo nella situazione di potere, come, per esempio, mi trovo nei due fondamentali, primitivi poteri: respirare e muovermi. Il bambino si trova nella capacità di giocare senza darsene pensiero; essa gli arriva prima di comprenderla. La mia stessa volontà è un potere in cui mi trovo prima di desiderarlo e conoscerlo: io posso volere. Perciò, almeno al loro sorgere, i poteri che innescano anche le più semplici operazioni non sono il risultato di una mia scelta, ma anzi qualcosa di patito, poiché mi trovo nella condizione di potere anteriormente a qualsiasi presa di posizione della mia libertà e del mio sapere” (pp. 69-70).
“L’uomo è uomo perché nessun’altra realtà, escluso Dio, può come lui, Perciò è quanto di più vicino a Dio esista. La vera domanda quindi non è «Che cos’è?», ma «Che cosa può?». Sicché il criterio per distinguere le cose e riconoscerle, collocandole in una scala, non è l’essere, ma il potere; non sono le forme, ma le forze” (p. 72).
“Il punto di partenza è innovativo, poiché non si comincia con il pensiero, o con quanto è “spirituale”, ma con il corpo e, per giunta, con poteri del corpo. Per Spinoza, mantenere la potenza del corpo significa corrispondere alla propria natura, stando all’altezza della Potenza divina da cui ogni forza deriva. Ecco quindi il compito dell’etica: indicare come un corpo possa stare all’altezza della propria potenza. Lo spunto non è quindi: «Come collimare con il proprio dovere?» (tale domanda è legittima, ma derivata e quindi successiva), bensì: «Come corrispondere al proprio potere?»” (p. 73).
“Insomma, il dovere dell’uomo è decidere di onorare il proprio potere, che lo rende l’essere più somigliante alla Somma Potenza. Perciò «la beatitudine non è il premio della virtù, ma è la virtù stessa»; la forza è già il premio. Sicché “potere” è la prima dotazione dell’uomo, il suo compito e il suo compimento” (p. 75).
“Si vuole “potere” per l’ottima ragione che si desidera la vita, dato che essa è coestensiva al fascio di poteri che la rendono effettiva: se non posso respirare, non vivo. Voler “potere” significa apprezzare, stimare, il fatto di trovarsi in condizione di potere, tanto da decidere di mantenersi in tale situazione” (pp. 80-81).
“Il nevrotico è caratterizzato dal fatto di poter includere in sé solo poco non-essere; davanti al pericolo del non-essere egli si rifugia nella sua fortezza piccola e angusta. L’uomo qualunque può portare in sé una dose limitata di non-essere; l’uomo creativo una dose grande; e Dio […] una dose infinita.
Troppo facile «voler vivere», «voler potere», da sani, belli e ricchi; non serve chissà quale forza. È persona fiacca chi scansa furbescamente tutto quanto mortifica. È invece potentissimo chi onora la vita, anche se malato, denigrato, povero o solo, magari a motivo della propria originalità creativa che lo esclude dal gusto comune… Non si tratta di alcuna mistificazione della debolezza, ma anzi si riconosce la presenza di tanta forza quanto negativo è accolto nel proprio «Sì!» alla vita. Che stupefacente energia vibra nel disabile che decide di stare al mondo, di voler potere, malgrado il suo vigore sia ridotto. L’approvazione della propria vita, nonostante l’impotenza che la offende, è l’espressione più alta di possanza. La finezza di Tillich consiste nel mostrare che la potenza, innanzitutto, non ha a che vedere né con la sopraffazione né con l’immagine grossolana e banale della prestanza gagliarda, ma originariamente consiste nella forza di dire «Amen!» alla vita, benché costellata di non-essere e impotenza. Una persona è tanto potente quanto è capace di fidarsi del senso della vita (ecco le virtù della fede e della speranza!), benché spesso sia costretta all’impotenza. Letta in questa luce, l’impotenza inerme del martire è la manifestazione vittoriosa della sua indicibile possanza. Insomma, il potere non ha solo la forma dell’impeto, ma anche quella della resistenza: posso resistere al vento contrario, a una spinta che mi farebbe cadere, posso sopportare un peso, sostenere una situazione faticosa, una malattia, una perdita, una delusione. A partire da ciò, Tillich scopre la giustizia al cuore stesso del potere” (pp. 81-82).
“Più chiaramente di Tillich, Passeri sostiene che la resistenza non è la modalità di potere attiva solo in caso di fallimento dello slancio e dell’impeto, ma è la normale, fisiologica e necessaria forma della possanza. Infatti, il potere si concretizza, divenendo effettivo, unicamente di fronte a qualcosa che gli resiste, lo affronta e gli si oppone. Nessuna forza sarebbe reale e pratica senza sforzo: che cos’è la potenza del muscolo senza un peso da sollevare? Maggiore è il peso alzato, più robusto è il braccio” (p. 84).
“Se è vero che nel potere vibra il dovere: “Siano gli altri e le altre cose!”, la forma radicale della possanza è “generare”. In questo caso non solo si accetta la necessità che appaia qualcosa o qualcuno di resistente, ma addirittura la potenza è così ridondante da porre essa stessa chi la fronteggia. Un uomo e una donna che decidono di diventare genitori non configurano la propria energia solo acconsentendo che capiti qualcosa o qualcuno che si opponga loro, ma altresì desiderano che ci sia qualcuno che li affronti, corrisponda, stia di fronte, faccia a faccia, a tal punto da essere a sua volta potente. Trovandosi in condizione di potere e giudicando buona siffatta situazione, essi possono e desiderano mettere altri in condizione di potere. In tal senso generare significa interessarsi carnalmente affinché qualcun altro abbia capacità: “Io ho il potere di far sì che tu possa. Io voglio che tu possa!”. Ciò conferisce alla generica energia la forma di fecondità, cioè l’espansione del proprio potere, ottenuta dando vita esattamente a chi può fronteggiarlo” (p. 86).
“Insomma: si genera perché si è vitali e perché si muore. Perciò il momento felice della consapevolezza, carnale ed emotiva, di potere fino a dare potere coincide con la precisa sensazione dell’indisponibilità del potere stesso e la consapevolezza della sua fine. Ciò non si coglie solo nell’esperienza della generazione, ma in ogni espressione di forza” (p. 88).
“La vittoria del Signore [nelle tentazioni] non consiste, quindi, nel rifiuto del potere promessogli, in nome di chissà quale ascetica rinuncia a ogni forma di rilevanza e grandezza. Piuttosto, il suo trionfo coincide con il netto rifiuto di considerare il diavolo come potente. L’oggetto in questione non è il potere, ma chi realmente lo detiene e chi, come tale, può effettivamente elargirlo” (p. 97).
“«L’accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte» (Ap 12,10). Questa denominazione del diavolo mostra un aspetto poco pensato: il suo vero bersaglio non è l’uomo, ma Dio. Il tentatore, spingendo i figli di Adamo verso la prepotenza, punta a ottenere capi di accusa contro l’uomo da portare davanti a Dio. E come se il suo scopo fosse addurre prove dell’infame, vergognosa, omicida ingiustizia degli uomini, al fine di convincere Dio circa l’insensatezza, l’assurdità della sua incomprensibile premura verso questi grumi di terra che respira. Il vero tentato dal Satana non è l’uomo, ma Dio, che dovrebbe smetterla di stimare esseri così spregevoli. In questo senso il Satana è diavolo, vale a dire divisore: cerca di separare Dio dalla terra e dalla carne, che non risulta neanche capace di onorare i doni ricevuti. Siamo franchi! Il lavoro gli riesce benissimo, e non ha nemmeno torto” (pp. 103-104).
“Rubricando frettolosamente questi gesti di Cristo sotto il segno dell’amore o della “misericordia”, a volte li si riduce ad atti di generica bontà e condiscendenza, quando non a segnali di eccentrica contrapposizione al sistema culturale e religioso stabilito. Certo, gli stupendi gesti salvifici del Signore manifestano l’inattesa compassione e l’incomprensibile solidarietà di Dio per noi, ma ciò non dovrebbe far dimenticare lo spunto, la scintilla senza cui tale amoroso incendio non divamperebbe. Pieno del potente Spirito di YHWH, Gesù può scendere nel regno dell’impotenza umana. Quando tocca un malato, perdona un peccatore, libera un ossesso, risuscita un morto, Cristo discende agli inferi, fino al profondo sheol d’ogni uomo e del mondo, non temendone il contagio, tanto è potente. Tutto è puro per chi è Potente. I suoi miracoli sono innanzitutto gesti di potenza, perciò sono pieni d’amore e di misericordia, capaci di ristabilire la giustizia della carne, sottraendola agli inferi, riconsegnandola allo splendore del suo originario potere. Ciò permette di cogliere una sfumatura importante nella cattiveria umana, disinteressata alla debolezza della carne altrui. Innanzitutto, non si tratta di “egoismo” o di “mancanza di carità”; piuttosto è la certificazione della propria impotenza che fa temere perfino il semplice contatto con quanto è vicino allo sheol. Spaventati dalla propria impotenza, gli uomini e le donne girano alla larga da tutto ciò che è sheol, atterriti dall’eventuale contagio. L’impotente teme d’essere contaminato dall’impotenza altrui, perciò è egoista e cattivo” (pp. 108-109).
“A differenza di altre figure dotate della Ruah di YHWH, la potenza accordata alla carne del Figlio dell’Altissimo è presentata come una forza “compiuta”, non solo per il singolare e irripetibile grado della sua presenza, ma anche a motivo della pienezza del suo esercizio, giacché si manifesta in ogni caso come potere che (ri)mette altri in condizione di potere: guarigione ai malati, libertà ai prigionieri (quelli che stanno «sotto il potere del diavolo»), perdono ai peccatori, vita ai morti” (p. 110).
“Per prima cosa «Figlio» significa essere stato messo in condizione di potere, essere generato” (p. 113).
“Sorvolando su questa sfumatura, generalmente si legge l’affermazione di Gesù come ammissione del potere del Padre di allontanare la morte da lui: “Tu puoi allontanarmi il calice”. Ma la preghiera del Signore è molto più ampia, giacché confessa che il Padre può tutto («Tutto è possibile a te»). Non siamo di fronte alla semplice richiesta di scansargli la morte, bensì alla più alta professione di fede di Gesù, fatta proprio nel momento della paura, tristezza e angoscia: Dio è un Padre che può tutto!33 Vale a dire: il Padre potrebbe evitargli la morte, ma qualora decidesse di non schivargliela, potendo tutto, è capace perfino di richiamarlo dai morti. Infatti, chi può tutto è «Padre», colui che da sempre e a tutti i costi genera, (ri-)mettendo altri in condizione di potere. E come potrebbe essere davvero onnipotente, se non fosse il Padre? E come potrebbe essere davvero il Padre, se non fosse onnipotente? Su questa fede nell’onnipotenza del Papà poggia la totale obbedienza del Figlio: «non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu»; sa che si comporterà sempre da Padre, sa che in ogni caso genererà” (p. 119).
“In Apocalisse sfocia la corrente che solca tutte le Sacre Scritture: qualsiasi atto di fede è un atto di fede nel potere. Non esiste alcun genere di affidamento che non sia mosso dal presentimento di un potere raggiungibile, poiché chi e quanto è considerato affidabile lo è in forza e nella misura della sua potenza. Credere nel Dio di Gesù significa riconoscere esclusivamente a lui e al suo Cristo un potere immenso, capace di creare ogni cosa e salvare ogni carne dalla morte. Niente di meno. Tale decisione conferisce al credente anche un tono contestatore, gettandolo nella mischia di una sanguinosa lotta di potere, combattuta entro i confini intimi d’ogni anima e sul campo di battaglia della storia di tutti. Del resto, a ben vedere, ogni peccato altro non è che una singolare espressione d’incredulità nella potenza di Dio. L’avaro non crede che Dio possa dare il pane quotidiano a tutti, sicché accumula e, in genere, ruba. Si diviene superbi o invidiosi, non ritenendo che Dio possa garantire a ciascuno un posto degno di sé, perciò non si è disposti ad ammettere che esista bellezza, bontà e verità appartenenti ad altri. L’accidioso nega che Dio possa agire nell’adesso e nell’oggi personale, sociale o ecclesiale; poteva solo “ieri” e, magari, lo potrà “domani”…” (pp. 129-130).
“Si crede davvero, se la fede non dà o restituisce poteri? A chi si sta credendo, se la fede non ridona potere? È davvero «potenza della fede», se essa non mette altri in condizione di potere, onorando la promessa fatta a ogni bambino venuto al mondo? Anche le beatitudini (Mt 5,3-12), vanno lette nell’ottica del potere restituito. Il Signore, infatti, compiacendosi, si congratula con varie categorie di persone, poiché finalmente possono vivere questi atteggiamenti evangelici, ne sono abilitati: hanno il potere di vivere da poveri, da miti cioè disarmati; hanno la forza di sostenere l’afflizione e il pianto; sono così possenti da resistere nella fame e nella sete di giustizia; talmente vitali da permettersi il lusso di un cuore puro, capace di guardare ogni cosa con giustizia; così forti da non eliminare i nemici, cercando la pace; hanno la possanza di vivere da perseguitati, fino al martirio sanguinoso, o nelle estenuanti pazienze d’ogni giorno, passione quotidiana che fa morire ogni credente come martire a gloria di Dio, senza la propria gloria.
A ogni cristiano, alla Chiesa tutta, a ogni uomo è «dato il potere di diventare figli di Dio» (Gv 1,12); giacché figli si nasce, ma soprattutto si diventa, permettendo alla Potenza di Dio, al suo Spirito, di renderci somiglianti a Colui che tutto può, avendo tutto ricevuto. A noi è dato il medesimo Spirito Santo di Cristo; non diverso, non meno, poiché Cristo dona «senza misura» lo Spirito di cui è pieno (Gv 3,34). «Sappiamo noi cosa può un corpo sotto l’azione dello Spirito?». Perché allora siamo così impotenti? Non abbiamo fede? O la fede non è ancora riuscita a mettere nel nostro petto un cuore di carne?” (pp. 133-134)
“Detto francamente, sembrerebbe ridicolo che le ossa possano rivivere; e risibile appare la formidabile potenza attribuita allo Spirito di aprire i sepolcri e incoronare la carne. Tuttavia, conviene ricordare che ride bene chi ride ultimo” (p. 136).
Tags: Dio Potere